Kurdistan: ancora una “morte piccina” e ingiusta
Osservatorio repressione – 9 giugno 2023, di Gianni Sartori
ciao mæ ‘nin l’eredítaë
l’è ascusa
‘nte sta çittaë
ch’a brûxa ch’a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.
Così cantava De André in Sidùn, pensando ai bambini palestinesi e libanesi.
Oggi come oggi, probabilmente, dedicherebbe queste parole anche a tanti bambini curdi.
Anche al piccolo Erdem Aşkan, di cinque anni. Morto non sotto le bombe al fosforo, ma per un “normale” incidente stradale, uno come tanti.
Ma comunque – per le modalità e per gli eventi successivi – organico al clima di repressione genocida che nella Turchia di Erdogan si abbatte quotidianamente sulla popolazione curda. Minori compresi.
L’incidente si era verificato sulla strada per Van nella provincia di Hakkari (Bakur, Kurdistan del Nord sotto amministrazione turca) quando un veicolo blindato dell’esercito aveva investito Erdem Aşkan, un bambino di cinque anni. Alla guida del mezzo un sergente turco (qualificato come “esperto” e identificato solo con le iniziali A.K.P.) della Gendarmeria del distretto di Yüksekova. Per l’impatto il piccolo veniva proiettato a oltre cinquanta metri ed era deceduto. Tuttavia, invece di soccorrerlo, il militare aveva puntato la sua arma contro le persone che avevano assistito al dramma per allontanarsi immediatamente.
Sottoposto in un primo momento al fermo di polizia, dopo l’interrogatorio (nonostante la gravità del suo comportamento sul luogo dell’incidente) veniva rimesso in libertà se pur “condizionale”. Come massima restrizione, gli veniva ritirata la patente.
Un episodio che riporta all’ordine del giorno la questione della sicurezza sulle strade del Bakur, percorse quotidianamente (e in genere ad alta velocità) da migliaia di veicoli militari, in buona parte blindati.
Stando ai dati forniti da TIHV (Fondazione dei diritti dell’Uomo della Turchia) tra il 2018 e il 2022 almeno una ventina di persone (di cui una metà bambini) sono morte per essere state investite da tali mezzi. Oltre una cinquantina i feriti gravi (di cui almeno quindici sotto i 18 anni).
TIHV denuncia inoltre che per i responsabili degli incidenti (militari o poliziotti) praticamente non esistono sanzioni penali.
Rimane invece dietro le sbarre il giornalista curdo Abdurrahman Gök, “reo” di aver fotografato (e pubblicato l’immagine) un giovane curdo ucciso dalla polizia durante il Newroz del 21 marzo 2017. Non solo. Non gli vengono concesse visite e anche una sua lettera ad un altro giornalista è stata confiscata in questi giorni.
Forse perché vi era scritto che “questa lettera verrà completata quando sarà garantita la libertà di espressione”.
Destino assai diverso quello di un altro curdo, Hakan Fidan, già ministro dei servizi segreti turchi (MIT) sospettato di essere responsabile della morte e del sequestro di centinaia di curdi e altri oppositori in varie parti del pianeta.
Forse come riconoscimento per la sua esperienza a livello internazionale, Erdogan lo ha piazzato a capo del ministero degli affari esteri.
Tra i suoi precedenti, nel 2014 per giustificare un attacco militare in Siria (contro i curdi del Rojava, ça va sans dire) avrebbe detto (e pare scritto anche su YouTube, poi cancellato) che “Se fosse necessario potrei inviare quattro persone in Siria per lanciare una decina di granate contro la Turchia”.
Evidentemente nascere curdi non è una garanzia. Si può diventare un collaborazionista, un “ascaro” anche ai danni del proprio stesso popolo.
Di origini curde anche l’ex ministro delle Finanze Mehmet Simsek, attuale ministro dell’economia. In passato aveva goduto di una certa notorietà affermando che “le donne che lavorano sono la causa principale della disoccupazione”.
Ma oltre ad arruolare nei suoi ministeri questi – e altri come Cevdet Yılmaz – personaggi di origine curda, Erdogan ha portato in Parlamento vari esponenti di HUDAPAR, partito conosciuto come gli Hezbollah curdi (presumibilmente manovrati dai servizi e utilizzati per disgregare il movimento curdo in generale e quello delle donne curde in particolare).
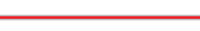
INDIA SENZA PACE: PROSEGUE LO SCONTRO SANGUINOSO TRA GUERRIGLIA MAOISTA (naxaliti) E FORZE GOVERNATIVE
Gianni Sartori
Quando è stata la prima volta che ho sentito parlare dei naxaliti? Doveva essere il 1971 o il ’72. Quando, su “Re Nudo” (rivista underground, vagamente situazionista, fondata tra gli altri da Andrea Valcarenghi) venne pubblicata la lettera di un ex fricchettone che era partito in autostop per l’India con motivazioni nobili (la meditazione, la ricerca spirituale…) e altre più prosaiche ( farsi – o strafarsi – di canne). Per la cronaca: era lo stesso che avevo portato in vespa fino al casello dell’autostrada.
Poi, vista e valutata la situazione, si era integrato in una delle numerose organizzazioni maoiste all’epoca presenti in India.
Appunto quella dei naxaliti, nati qualche anno prima nel villaggio di Naxalbari (distretto di Darjeeling, stato del Bengala Occidentale).
Qui il 18 maggio 1967 scoppiava una rivolta (ispirata e guidata da Charu Majumdar, Kanu Sanyal e Jangal Santhal) con qualche centinaio di contadini poveri che andarono a riprendersi le terre, i campi e le fattorie occupandole. Attaccando, armati di archi e frecce, guardie e proprietari terrieri. La ribellione durò alcuni mesi e – come da manuale – venne affogata nel sangue dalle armi automatiche dei militari. A cui si rispose con ricorrenti insorgenze anti-governative e con la nascita di un movimento di resistenza popolare armato che prese il nome dal villaggio ribelle.
Attualmente nei loro ranghi i combattenti sarebbero almeno 15-20mila, a cui va aggiunta una quantità maggiore (40-50mila) di sostenitori (la “seconda linea”), ugualmente attivi anche se armati più che altro di archi, frecce e altre armi rudimentali.
La loro presenza è significativa soprattutto in Andhra Pradesh, Maharashta, Chhattisgarh e Telangana.
Tra i principali obiettivi della loro lotta avevano preso di mira le Zone Economiche Speciali. Quelle che ormai da qualche decennio il governo mette a disposizione degli imprenditori concedendo importanti vantaggi. Sia di natura fiscale, sia nella realizzazione di infrastrutture (in genere devastanti per i territori e per le comunità indigene). Per i maoisti tali politiche economiche non sarebbero altro che “la prosecuzione del colonialismo con altri mezzi”. Inoltre, frantumando le comunità tribali, ne determinano l’espulsione o l’emarginazione.
Un discorso che vale, ovviamente, oltre che per i tribali (adivasi) anche per i dalit, per i contadini poveri e per tutti i diseredati dell’immenso Paese.
Prendendo qualche anno a caso (per esempio il 2018 e il 2019), possiamo identificare con chiarezza quali siano i metodi adottati dal governo indiano per imporre tali logiche di oppressione e sfruttamento.
Il 18 marzo 2019 negli scontri tra vigilantes della Vedanta Limited (filiale indiana della società britannica Vedanta Resources, proprietà del miliardario Anil Agarwal) perdevano la vita due persone (quelle accertate, ma non si escludevano altre vittime tra i manifestanti)
Gli abitanti di Rengalpali, Bandhaguda, Kothajuar e altri villaggi si erano radunati per protestare contro l’espansione (e gli inevitabili “danni collaterali”) della fabbrica di alluminio del gigante minerario nell’Odisha. In cambio chiedevano, come modesta riparazione, posti di lavoro per le famiglie sfollate a causa dei lavori di ampliamento.
Il servizio di sicurezza aveva reagito con estrema violenza al tentativo della folla di forzare i cancelli per entrare nello stabilimento. Si trattava dei membri della Odisha Industrial Security Force, una polizia ausiliaria ufficialmente alle dipendenze della Stato, ma che agiva come una milizia privata al servizio di industriali e proprietari di miniere.
Un manifestante era rimasto ucciso e diversi altri feriti gravemente.
Negli scontri successivi l’esasperazione degli abitanti provocava la distruzione e l’incendio del posto di guardia e anche un poliziotto perdeva la vita.
Un anno prima (il 23 maggio 2018) la polizia aveva sparato contro i manifestanti radunatisi a migliaia davanti a una altra azienda della Vedanta, lo stabilimento Sterlite per la produzione di rame nello stato del Tamil Nadu. Sul terreno erano rimasti 13 morti (tra cui una ragazza di 17 anni) e una sessantina di feriti. La popolazione della città di Thoothukudi chiedeva la chiusura della fabbrica che inquinava pesantemente sia l’aria che l’acqua in tutto il territorio circostante.
Vicende simili sono avvenute quasi regolarmente nel corso degli ultimi anni.
Ma se ci occupiamo in particolare della situazione degli indigeni adivasi (le popolazioni indigene della “cintura delle foreste” dell’India centrale detta anche “cintura tribale”) è perché non rischiano di perdere soltanto linguaggio, tradizioni e identità. Molto semplicemente nei loro confronti è in atto qualcosa che ricorda molto l’etnocidio.
Da tempo infatti è in gioco la loro stessa sopravvivenza fisica.
Soprattutto da quando su questi territori si è posata la cupidigia delle multinazionali, desiderose di impossessarsi dei ricchi giacimenti di minerali grazie ai Memorandum d’intesa (Mou) stipulati con il governo. Tra i casi più drammatici, le colline dell’Orissa abitate dai kondh e ricche di bauxite.
In nome dell’estrattivismo governi e multinazionali degli adivasi ne hanno fatto strage. Utilizzando metodi indegni: esecuzioni extragiudiziali, stupri di donne indigene, arresti e detenzioni arbitrarie.
Anche perché ai danni delle popolazioni indigene non operano soltanto le compagnie minerarie.
Nel 2006 suscitò scalpore l’arresto dell’eco-attivista Medha Patkar, da mesi in sciopero della fame contro il «piano Narmada» (Narmada Valley Development Project). La sua protesta era solo l’ultimo episodio di una lotta già allora lunga venti anni contro la distruzione di centinaia di villaggi e di intere vallate e foreste.
Lo sfruttamento delle risorse idriche in India aveva determinato il progetto di oltre 3.000 dighe sul fiume Narmada e i suoi affluenti. Verso la fine del 2005 si era celebrato il ventesimo anniversario dell’inizio della resistenza popolare contro questi devastanti interventi che – oltre alla dignità e ai diritti dei nativi – calpestavano ogni rispetto per l’ambiente naturale. Interi villaggi erano scomparsi sotto le acque dei bacini mentre contadini e popolazioni tribali a loro volta “scomparivano” negli slums delle metropoli, cessando di esistere come comunità. A fianco di Medha Paktar si era schierata la scrittrice Arundhati Roy, da sempre attiva in difesa dei nativi. Ma poi, com’era prevedibile, le dighe vennero completate e le popolazioni rimaste dovettero rassegnarsi a raggiungere coloro che già da tempo si erano rifugiati negli slums, sradicati e marginalizzati.
Tutto questo mentre i media internazionali esaltavano la “irresistibile crescita economica dell’India, della Borsa di Bombay che va a mille, di una ricchezza complessiva enorme, dei ristoranti pieni e dei consumi di lusso”. Coprendo con un velo impietoso la realtà sempre più drammatica di un’India contadina e tribale. Alle commemorazioni del 2005 avevano partecipato anche i superstiti di Bhopal. Reduci da una marcia di ottocento km. fino a Delhi per chiedere la rimozione della fabbrica chimica e la bonifica del terreno. Come da manuale la polizia, nonostante fosse una marcia pacifica, li aveva duramente caricati.
Ma, come per la biodiversità e le lingue ancestrali, altre due mappe coincidono. Quella della “cintura tribale” si sovrappone al “corridoio rosso”.
Da vari decenni la resistenza degli adivasi, dei dalit, dei contadini poveri, delle minoranze religiose… opera in sintonia (più o meno, non mancano certo frizioni e contenziosi) con i guerriglieri maoisti del Pci-m, più noti appunto come naxaliti.
Un po’ di Storia.
Alla fine degli anni sessanta, preso atto della temporanea sconfitta, un militante maoista – Charu Majumdar – iniziò a lavorare per costituire un’organizzazione in grado di operare su tutto il territorio indiano. Così nacque il «Comitato di Coordinamento dei Comunisti di tutta l’India» (AICCCR) nella prospettiva di un’insurrezione generale che coinvolgesse, oltre ai contadini e ai diseredati delle metropoli, anche gli adivasi (le popolazioni tribali preinduiste) e i dalit (gli “intoccabili”, vittime del sistema delle caste).
Per quanto dilaniato dalle faide interne (in particolare tra filo-cinesi e filo-sovietici) il movimento non mancò di attirare anche molti giovani provenienti dalle università. E in alcuni Stati (Andra Pradesh, Chhattisgarh, West Bengala, Bihar, Orissa, Karnataka… quello che poi verrà denominato “Corridoio rosso”) gli insorti arrivarono a sostituire le autorità ufficiali con governi locali autonomi in grado di amministrare la giustizia, riscuotere tributi, difendere il territorio dalla repressione statale. Almeno temporaneamente perché nel 1971 Indira Gandhi lanciò una sistematica campagna di rastrellamenti decimando il movimento guerrigliero. Catturato nel 1972 e rinchiuso nel carcere, Majumdar morì per le torture subite.
Qualche anno fa suscitò scalpore il fatto che un loro leader (Mallojula Koteswar Rao, poi ucciso dalle forze di sicurezza nel 2011) avesse chiesto alla scrittrice Arundhati Roy di svolgere un ruolo di mediatrice con il governo. Da parte sua Arundhati aveva accettato ma il governo indiano – così sensibile alle sirene delle compagnie minerarie e delle fabbriche di auto – si mostrò poco interessato.
Contro naxaliti e tribali alla fine del 2009 era stata avviata una nuova, violenta campagna militare denominata “Caccia Verde” con l’impiego di più di 75mila soldati.
Ma la resistenza tribale si era saputa difendere, anche con azioni clamorose. Come nel 2010 quando aveva teso una imboscata ad un convoglio militare uccidendo 76 soldati.
Dopo anni di scontri alternati a fragili tregue, su questo conflitto a bassa (relativamente bassa) intensità, sembrava dover calare un definitivo silenzio. Rintanati nel folto delle foreste dell’India centrali, i ribelli apparivano intenzionati a non sortirne. Invece erano tornati prepotentemente in azione. Sia con la clamorosa “imboscata di Sukma”(Burkapal, 24 aprile 2017) in cui avevano perso la vita 26 paramilitari della CRPF, sia all’inizio del 2018 quando – il 24 gennaio – quattro agenti della polizia sono rimasti uccisi al margine della foresta di Abujhmad (nello stato del Chhattisgarth).
A Sukma soldati e paramilitari sorvegliavano in armi i lavori per la costruzione di una strada che attraversava i territori tribali per conto di un gruppo industriale. L’attacco venne rivendicato dal DKSZC (Dand Karanya Special Zone Committee) del PCI (maoista). Venne giustificato come una “risposta di autodifesa”. Non solo nei confronti delle politiche governative (definite “antipopolari”), ma soprattutto “per le atrocità sessuali, gli stupri commessi dalle forze di sicurezza contro le donne e le ragazze tribali”. In sostanza “per la dignità e il rispetto delle donne tribali”. Nel loro comunicato (di stile guevarista) i guerriglieri si rivolgevano anche ai soldati con queste parole: “Non siete i nostri nemici. Tanto meno nemici di classe. Tuttavia siete al servizio dello sfruttamento operato dal governo. Vi rivolgiamo un appello affinché smettiate di combattere schierati al fianco dei politici sfuttatori, dei grandi imprenditori, delle compagnie nazionali e internazionali, delle mafie, dei fascisti indù (un riferimento al partito di Narendra Damodardas Modi, il Bharatiya Janata Party nda) etc. che sono nemici dei dalit, dei tribali, delle minoranze religiose e delle donne. Soldati, non sprecate la vostra vita per difendere tali personaggi e le loro ricchezze. Lasciate l’esercito e prendete parte alla lotta popolare”.
Tra l’altro del massacro vennero accusati oltre 120 tribali poi risultati del tutto estranei (ma liberati solo nel 2022, dopo cinque anni trascorsi in carcere da cui qualcuno era già uscito con i piedi in avanti).
Azioni simili, per quanto meno cruente, a sostegno della dignità delle donne tribali si registrarono anche nel 2020 quando, il 15 gennaio, esponenti dell’esercito guerrigliero di liberazione popolare (PLGA) attaccarono un resort di Attamala (distretto di Wayanad, nel Kerala) utilizzato per lo sfruttamento sessuale di donne adivasi da parte dei turisti.
Dopo aver distrutto porte e finestre e incendiato i mobili, avevano appeso cartelli e manifesti su cui si leggeva: “L’attacco è contro la rappresentazione degli adivasi come una merce da esporre e mettere a disposizione dei turisti. Tutti i proprietari di resort che rappresentano una minaccia all’esistenza pacifica degli adivasi saranno sloggiati con la forza”. Ovviamente questa difesa dell’identità indigena non ha niente che vedere con il “pittoresco” amato dai turisti. Viene intesa come una componente fondamentale della resistenza di ampi settori popolari (ripeto: adivasi, dalit, contadini poveri, diseredati delle città, classi subalterne in genere…) nei riguardi dei meccanismi neoliberisti che devastano e annichiliscono territori, ambiente e popolazioni.
In precedenza, nel 2014, c’era già stato un attacco del PLGA contro l’Agraham Resort di Thirunelli e un altro nel 2015 (contro un albergo di proprietà statale reso inagibile).
Nel 2019 invece era toccato al resort Upavan di Vythiri.
Concludo con qualche aggiornamento per questo gennaio 2025.
Il 6 gennaio l’esplosione di un IED (Improvised Explosive Device – Ordigno esplosivo improvvisato) lungo la strada Kutru-Bedre (distretto di Bijapur nel Chhattisgarh) uccideva sul colpo otto paramilitari delle forze di sicurezza che rientravano da un’operazione anti-guerriglia nella regione di Abujhmad. Mancano per ora informazioni aggiornate sulla sorte dei feriti. L’operazione condotta contro i maoisti, durata alcuni giorni, si era conclusa con l’uccisione di cinque naxaliti (veri o presunti) e la perdita di un membro della Guardia di riserva del distretto (DRG). E appartenevano appunto alla DRG la metà dei paramilitari uccisi nell’imboscata del 6 gennaio. Quattro invece facevano parte dei Bastar Fighters, altra forza contro-insurrezionale. Dieci giorni dopo, il 16 gennaio, arrivava la risposta, durissima.
La prima impressione è stata quella di una rappresaglia. O anche di un faida infinita. Almeno 18 maoisti venivano ammazzati in uno scontro a fuoco tra polizia (DRG di Bijapur, Sukma e Dantewada; a cui si erano uniti vari Battaglioni di commando per l’azione risolutiva – CoBRA – delle Forze di polizia di riserva centrale – CRPFF) e combattenti del Primo battaglione dell’Esercito guerrigliero di liberazione del popolo. La vera e propria battaglia, durata l’intera giornata, si era svolta nelle foreste del South Bastar, nei pressi della frontiera di Telengana (distretto di Bijapur, sempre nello Stato del Chhattisgarh). La maggior parte dei corpi, una dozzina, venivano recuperati nelle zone frontaliere delle foreste di Tumrel, Sigampalli, Pujarikanker e Malempenta. Tra i caduti, il segretario di Stato maoista Telengana del CPI, Bade Chokka Rao (Damodhar).
Per completezza va detto che non mancano certo “contraddizioni in seno al popolo” (per restare in clima “maoista”). Anche sinceri democratici, attivisti ambientali e pacifisti (non filogovernativi), si mostrano talvolta molto critici nei confronti delle milizie naxalite. Arrivando ad accusarli sbrigativamente di essere “persone accecate dalla ideologia, brutali e violente, sicuramente non migliori e forse peggiori del sistema che dichiarano di voler cambiare”. Non solo, talvolta il controllo che comunque esercitano sulle tribù nelle aree occupate sarebbe “ferreo e spietato”. Le contraddizioni quindi ci sono. Ma non per questo – almeno credo – si dovrebbe buttare il bambino (“la resistenza, gli ideali socialisti…) con l’acqua sporca (eventuali rigurgiti stalinisti). L’esperienza del PKK, della sua innegabile evoluzione politica in chiave democratica, libertaria, femminista, ecologista…sta lì a dimostrarlo.
Ops, quasi dimenticavo. In anni più recenti giunse qualche notizia sul fricchettone diventato maoista in India. Dopo qualche mese, presumibilmente stremato da sanguisughe, larve che si infilavano nelle piaghe dei piedi, umidità, fame, stanchezza e paura…aveva abbandonato il campo. Le ultime notizie lo davano in cammino (letteralmente: a piedi) verso il Nepal. Da qui in poi se ne persero le tracce. Mi auguro che la vita sia stata buona con lui. In fondo, anche se solo per qualche mese, aveva almeno tentato di rovesciare l’ordine ingiusto del mondo.
Gianni Sartori
DOPO 49 ANNI, LEONARD PELTIER AGLI ARRESTI DOMICILIARI
Gianni Sartori
Difficile stabilire quanto abbiano contribuito film come “Soldato Blu” e “Piccolo grande uomo” a decolonizzare l’immaginario collettivo (o almeno quello degli spettatori) sulla questione degli Indiani d’America (e più in generale delle tante comunità indigene colonizzate, massacrate, talvolta estinte dall’opera “civilizzatrice” dell’Uomo Bianco).
Rappresentarono comunque un rovesciamento di prospettiva (anche perché le immagini del Sand Creek e del Washita evocavano prepontemente Mỹ Lai e il Vietnam), per quanto sempre all’interno della “Società della merce e dello spettacolo”. Ben più dirompente quanto avvenne a Wounded Knee nel 1973 e la vicenda di Leonard Peltier. In prigione dal 6 febbraio 1976, accusato di delitti attribuitigli dal Fbi per il suo impegno nella liberazione dei nativi americani.
Ormai ottantenne, l’esponente dell’American Indian Movement rischiava seriamente di crepare nella sua cella.
Soltanto pochi minuti prima dell’investitura di Donald Trump, Joe Biden ha commutato la pena all’ergastolo consentendogli gli arresti domiciliari.
Per quanto non graziato, dopo 49 anni di carcere e con seri problemi di salute, potrà almeno trascorrere il tempo che gli resta fuori dalle mura di un penitenziario.
Attivamente presente all’occupazione di Wounded Knee, Leonard venne in seguito accusato di aver preso parte all’uccisione di due agenti del FBI nella riserva di Pine Ridge nel 1975.
Un ripasso. Il 27 febbraio del 1973 circa 200 militanti armati dell’AIM occuparono l’insediamento di Wounded Knee (luogo di un efferato massacro contro i Lakota Minneconjou nel 1890). Richiedendo un’inchiesta sulla corrotta amministrazione della riserva di Pine Ridge e sulla sistematica violazione dei trattati firmati dal governo statunitense con le popolazione native. Intervennero centinaia di poliziotti, duemila agenti del FBI, blindati ed elicotteri che posero il villaggio sotto assedio.
Il massacro di Wounded Knee del 1890 rientrava nella sanguinaria repressione contro i seguaci del predicatore Wovoka (Quoitze Ow) e della “danza degli spiriti”. Quando venne assassinato anche il capo tradizionale dei Lakota Hunkpapa Toro Seduto, Tatanka Yotanka, con Tȟašúŋke Witkó uno dei vincitori nella battaglia del Little Bighorn.
Temendo di venir rinchiusi o uccisi, circa 400 nativi si erano rifugiati nell’accampamento di Big Foot (Heȟáka Glešká, fratellastro di Tatanka Yotanka) in un’altra riserva. Ma il 29 dicembre 1890 intervennero i vendicativi soldati del 7° cavalleria. Mentre si procedeva al disarmo degli indiani fuggitivi un colpo partito forse casualmente fornì il pretesto per la strage. Ai fucili si aggiunsero le cannonate che bombardarono il villaggio massacrando donne e bambini. Le vittime accertate tra gli indiani furono oltre 350.
A questo tragico evento si volevano richiamare gli aderenti all’AIM quando occuparono Wounded Knee dichiarandolo “territorio indipendente”.
Un’azione eclatante organizzata dopo l’occupazione di Alcatraz nel 1969, del monte Rushmore nel 1970 e dell’Ufficio degli affari indiani a Washington nel 1972.
Nei giorni successivi molte persone raggiunsero gli occupanti portando viveri e altri beni di prima necessità e vennero organizzate mense comunitarie, servizi sanitari e un piccolo ospedale. Nei settanta giorni dell’assedio si registrarono isolati colpi di fucile e due militanti dell’AIM persero la vita.
Ai primi di maggio (dopo circa settanta giorni di occupazione) il governo statunitense garantì di voler esaminare le loro richieste sulle violazioni dei trattati, la corruzione del Consiglio tribale collaborazionista, la revisione dei trattati del 1868…
A patto che deponessero le armi e ponessero fine all’occupazione. Così l’8 maggio 1973, col favore delle tenebre, i militanti si dispersero sfuggendo momentaneamente all’arresto.
Ma sui muri rimaneva la scritta “Bury My Heart at Wounded Knee” (titolo di un famoso libro di Dee Brown e poi di una canzone dell’indiana Piapot Buffy Saint-Marie).
Come c’era da aspettarsi, la situazione di Pine Ridge rimase inalterata e l’inchiesta promessa venne dimenticata.
Ma evidentmente non bastava. Negli anni successivi numerosi partecipanti e membri o simpatizzanti dell’Aim vennero assassinati o morirono in maniera non chiara, “accidentale” (si parla di circa 300 vittime). Si ritiene che le milizie native filogovernative abbiano così voluto “regolare i loro conti” nelle riserve.
Tra le vittime anche Anna Mae Aquash (a Wounded Knee si era sposata con un rito tradizionale e viene ricordata nella ballata di Buffy Saint-Marie), violentata e assassinata, le mani mozzate. Una vicenda impregnata di ombre e sospetti di “guerra sporca” (nei confronti sia del Fbi che delle milizie native filogovernative e forse anche di qualche frangia incontrollata dell’Aim), presumibilmente legata a quella di Leonard Peltier.
Inevitabile l’analogia con quanto accadde alle Black Panthers.
Peltier venne arrestato e condannato per l’uccisione, avvenuta in circostanze mai chiarite, di due agenti del FBI il 25 giugno 1975 nella riserva di Pine Ridge. Al processo i suoi avvocati subirono pesanti limitazioni e venne impedita la presentazione di testimoni a sua difesa. Oltre 140mila pagine del “dossier Peltier” rimangono tuttora inacessibili (anche agli avvocati) per ragioni di “sicurezza nazionale”.
Cos’altro aggiungere? Quando verrà la sua ora, seppellite il suo cuore a Wounded Knee.
Gianni Sartori
GRECIA: MANIFESTAZIONI PER LE VITTIME DELL’ALTA VELOCITA’ nell’incidente del 28 febbraio 2023
Gianni Sartori
Il 26 gennaio violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono svolti in varie località della Grecia, in particolare a Tessalonica e Atene. Le manifestazioni erano state indette dai familiari delle vittime, dai sindacati e da esponenti politici dell’opposizione per protestare contro quelle che considerano ”menzogne governative”. In riferimento alla catastrofe ferroviaria avvenuta poco prima della mezzanotte del 26 febbraio 2023 sulla linea Atene-Salonicco (gestita dalla società Hellenic Train che dal settembre 2017 fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) su un tratto a doppio binario con deviazioni e segnali elettrici che – pare – non abbiano funzionato. Il terribile incidente, uno scontro frontale tra un treno passeggeri carico di studenti (Intercity 62) e un treno merci, era avvenuto presso Tempi (a nord di Larissa, in Tessaglia) causando la morte di 57 persone (carbonizzate o per asfissia a causa dell’incendio come confermano i drammatici audio recuperati) e 85 feriti. Con buona parte delle carrozze rimaste letteralmente disintegrate. Da un anno a questa parte il governo ha cercato in ogni modo di assolversi da ogni responsabilità scaricando le colpe su un capostazione assunto recentemente. Salta agli occhi la meschinità di tale spiegazione poco plausibile. Come osservava un parente di alcune vittime “E’ mai possibile che nell’era della digitalizzazione, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale un disastro del genere dipenda dall’eventuale “momentanea distrazione” di una sola persona e non dalle gravissime carenze, già denunciate in passato, delle infrastrutture ferroviarie?”
Particolare inquietante, solo poche settimane prima la Commissione europea aveva deferito la Grecia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per inosservanza delle regole ferroviarie. Va anche ricordato che il sistema ferroviario ellenico – per quanto degradato – aveva suscitato l’interesse dell’Italia quando la Ue aveva costretto Atene a privatizzare e venderlo. Per cui dal settembre 2017 la società Hellenic Train è entrata a far parte del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. All’epoca dell’incidente manutenzione e gestione della rete ferroviaria erano di competenza dell’azienda statale greca OSE (Organismos Sidirodromon Ellados – Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος).
Negli scontri di domenica scorsa, la polizia ha fatto ampio uso di lacrimogeni e manganelli, mentre i manifestanti hanno lanciato pietre e – pare- qualche molotov.
Gianni Sartori