“Possa Kabul essere senza oro, ma non senza neve”. I danni ambientali nella giustizia di transizione e nella costruzione della pace

Huma Saeed, Agency for Peacebuilding (AP), 27 agosto 2025
Kabul, la capitale dell’Afghanistan con una popolazione di circa cinque milioni di abitanti, si trova ad affrontare una grave minaccia: si prevede che le sue falde acquifere si prosciugheranno entro il 2030, mettendo a repentaglio la sopravvivenza della città. Eppure, questa è solo una delle tante sfide ambientali che l’Afghanistan si trova ad affrontare, essendo il Paese tra i più vulnerabili agli impatti della crisi climatica. Sebbene l’Afghanistan sia uno dei minori contributori al mondo alle emissioni di gas serra, i suoi ghiacciai si stanno sciogliendo a causa dell’impatto accelerato dei cambiamenti climatici. Nel 2023, si è classificato al settimo posto tra i Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici e le Nazioni Unite hanno rilevato che è un Paese “sotto la costante minaccia di siccità, inondazioni, temperature estreme e degrado del suolo”. Sulla scia di decenni di conflitti, il degrado ambientale è una conseguenza spesso trascurata che esacerba le disuguaglianze esistenti e mina gli sforzi di costruzione della pace. In Paesi come l’Afghanistan, il danno ambientale deve essere riconosciuto come un pilastro fondamentale nel più ampio quadro della costruzione della pace e della giustizia di transizione. Ciò è particolarmente vero per le donne afghane, che sopportano il peso sproporzionato sia dei danni ambientali sia dell’ingiustizia sistemica causati da decenni di conflitto.
Table of Contents
ToggleIl nesso tra danno ambientale e giustizia di transizione nel contesto del conflitto
Nelle zone di conflitto , il degrado ambientale è sia un sintomo che un fattore di instabilità . La guerra accelera la deforestazione, il degrado del suolo, la contaminazione delle acque e l’inquinamento atmosferico, distruggendo risorse naturali cruciali per la sopravvivenza. Sebbene vi sia una chiara correlazione tra danni ambientali e violenza su larga scala, il discorso e la pratica della giustizia di transizione hanno per lo più fallito nel riconoscere o affrontare le conseguenze ambientali del conflitto. Questa negligenza limita la portata della giustizia e ostacola gli sforzi per raggiungere una ripresa post-conflitto completa e la responsabilità. Se la ricostruzione post-conflitto deve essere significativa, deve estendersi oltre la riconciliazione politica e la riforma istituzionale. Deve anche affrontare le ferite ambientali della guerra, quelle che continuano a segnare la terra e le persone molto tempo dopo che l’ultimo cannone ha taciuto.
In Afghanistan , decenni di guerra hanno devastato l’ambiente. Dalla deforestazione e dal degrado del suolo alle fuoriuscite di petrolio e alla contaminazione radioattiva, i sistemi naturali del paese sono stati sistematicamente distrutti. L’uso di munizioni all’uranio impoverito ha causato una contaminazione radioattiva residua. La demolizione dei sistemi di irrigazione ha avuto un grave impatto sulla produttività agricola. L’aumento dei casi di malattie respiratorie e cancro , probabilmente legati all’esposizione a sostanze nocive, sta iniziando solo ora a essere pienamente compreso. Le inondazioni, una minaccia ricorrente, causano circa 400 milioni di dollari di perdite economiche annuali e colpiscono 335.000 persone, in gran parte a causa della debolezza delle infrastrutture. La siccità causa anche sfollamenti di massa: oltre due milioni di persone sono state colpite solo nel 2018 e dal 2021 2,3 milioni di persone sono state sfollate, colpendo più duramente gli afghani più poveri, con l’85% che vive in condizioni vulnerabili e privo di resilienza climatica.
L’ingiustizia ambientale in Afghanistan colpisce in modo sproporzionato le donne . Nelle aree rurali, le donne sono le principali fornitrici di assistenza e di acqua, cibo e combustibile. Con l’aumento del degrado ambientale, devono percorrere distanze maggiori per procurarsi legna da ardere o acqua pulita, sacrificando tempo per l’istruzione o il reddito. Gli sfollamenti indotti dal clima , causati da siccità e inondazioni, espongono le donne a rischi maggiori, tra cui la violenza di genere e la mancanza di assistenza sanitaria e servizi igienico-sanitari. Questa esclusione consolida le disuguaglianze di genere e mina gli sforzi di costruzione della pace.
Questa ingiustizia ambientale prospera in un contesto di governance debole e impunità . Una valutazione ambientale post-conflitto dell’UNEP del 2003 ha avvertito che decenni di cattiva gestione avevano paralizzato i sistemi di risorse naturali dell’Afghanistan. Eppure poco è cambiato. Al contrario, gli sforzi di ricostruzione post-2001 hanno dato priorità alla spesa militare rispetto al consolidamento della pace e al recupero ambientale. Le lamentele locali sono state ignorate e i meccanismi di giustizia di transizione sono stati in gran parte assenti.
Inoltre, il degrado ambientale causato dalla guerra, dalla deforestazione e dalla cattiva gestione delle risorse idriche ha ricevuto scarsa attenzione, nonostante il suo impatto diretto sui mezzi di sussistenza e sulla stabilità a lungo termine. Questo squilibrio ha finito per minare una pace sostenibile , alimentando risentimento e indebolendo la legittimità sia delle istituzioni nazionali che degli attori internazionali.
La giustizia ambientale come strumento di costruzione della pace
Integrare la giustizia ambientale nella costruzione della pace post-conflitto offre un percorso per la guarigione sia delle comunità devastate dalla guerra sia degli ecosistemi danneggiati. In molte zone di conflitto, la guerra esacerba il degrado ambientale : le foreste vengono deforestate per ricavarne combustibile o vantaggi tattici, le fonti d’acqua vengono inquinate o trasformate in armi e i terreni coltivabili vengono lasciati sterili. Affrontare questi danni ambientali attraverso la riforestazione dei paesaggi, il ripristino della produttività agricola e la garanzia di un equo accesso all’acqua pulita può ridurre il rischio di future tensioni legate alle risorse. Inoltre, gli sforzi collaborativi di ripristino ambientale possono fungere da base per ricostruire la fiducia e la cooperazione tra gruppi precedentemente ostili o tra governo e cittadini , trasformando così gli interessi ecologici condivisi in un ponte per una pace sostenibile. Qualsiasi futuro sforzo di giustizia di transizione, in Afghanistan e altrove, deve includere le conseguenze ambientali della guerra. Le commissioni per la verità dovrebbero documentare i danni ecologici e il loro impatto sociale. Le riparazioni potrebbero comportare progetti di ripristino del territorio guidati dalle comunità o altre iniziative. Le riforme legali e istituzionali dovrebbero includere protezioni ambientali che affrontino esplicitamente le disparità di genere. Donatori e partner internazionali devono inoltre allineare gli obiettivi di peacebuilding e ambientali. Gli aiuti dovrebbero dare priorità alle infrastrutture ecocompatibili, alla governance delle risorse naturali e al sostegno diretto alle iniziative ambientali guidate dalle donne.
Il cammino dell’Afghanistan verso la pace è lungo e irto di battute d’arresto. Ma una cosa è certa: qualsiasi pace che non tenga conto dell’ambiente non è affatto pace; è solo una pausa prima della prossima crisi. Investendo nel risanamento ambientale, come la riforestazione, la gestione delle risorse idriche e l’agricoltura sostenibile, l’Afghanistan potrebbe gettare le basi per una pace a lungo termine, resilienza economica e stabilità sociale, offrendo alle comunità un’alternativa al conflitto e alla dipendenza dagli aiuti esteri.
Il vecchio detto afghano “Possa Kabul essere senza oro, ma non senza neve” esprime il profondo valore dell’acqua rispetto alla ricchezza, ma con le falde acquifere di Kabul in esaurimento e le nevicate in calo, la città ora corre il grave rischio di perdere sia la sua neve che il suo oro se la crisi non viene affrontata.
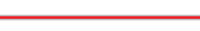
Lascia un commento