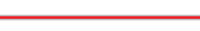Disarmo in Kurdistan: lezioni da un atto storico

Centro Studi Sereno Regis, 18 luglio 2025, di Matt Meyer*
Dopo decenni di lotta armata, un atto di disarmo in Kurdistan: il PKK depone le armi e apre un nuovo capitolo nonviolento nel movimento indipendentista curdo.
L’11 luglio, sulle colline del nord dell’Iraq, si è svolta una scena che avrebbe scosso anche il più esperto attivista per il disarmo. Scendendo lungo un ripido sentiero verso un’area improvvisata circondata da diverse centinaia di membri della comunità e sostenitori, 30 guerriglieri pesantemente armati, almeno la metà dei quali donne, si sono diretti verso un grande barile grigio per consegnare le armi.
Fanno parte del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o PKK, un gruppo paramilitare e politico formato nel 1978 per unire le popolazioni curde che vivono in Iraq, Iran, Siria e Turchia e lottare per l’indipendenza. Il PKK ha deciso di deporre le armi con una cerimonia di rogo delle scorte di armi portate da ciascuno dei guerriglieri. Sperano che questo atto unilaterale di cessate il fuoco dia inizio a un nuovo processo politico con il governo turco, che finora si è mostrato insensibile.
Il giorno e la decisione che lo ha preceduto non erano privi di profonde radici nella lotta per la libertà del Kurdistan. Nel 1923, quando la regione era governata dallo sceicco Mahmoud, re del Kurdistan, l’esercito britannico cercò di proteggere il suo recente mandato sulla regione mesopotamica e tutte le ricche riserve di petrolio che essa comportava. Mahmoud si rifugiò nella grotta di Jasana, dove l’11 luglio si svolse la cerimonia. Chiese ai suoi seguaci di trasferirsi nella regione per motivi di sicurezza e aiutò a pubblicare dalla grotta il primo giornale moderno di resistenza anticoloniale curdo. Nel corso dell’ultimo secolo, la grotta è stata utilizzata come importante rifugio per i resistenti armati e non violenti che hanno affrontato le forze anti-curde, compresa la campagna genocida Anfal di Saddam Hussein.
L’amato leader curdo, teorico e prigioniero politico di lunga data Abdullah Öcalan, fondatore del PKK, ha chiesto lo scioglimento del partito il 25 febbraio, a oltre 26 anni dalla sua cattura e dalla sua detenzione. L’attento seguito dato a tale appello da parte di gruppi all’interno del PKK – e il successivo appello di Öcalan ai combattenti del PKK a deporre le armi – ha portato agli eventi di disarmo dell’11 luglio.
C’è stata anche un’ampia dichiarazione da parte di un “Gruppo per la pace e la società democratica” emerso negli ultimi mesi. Formatosi in seguito a recenti incontri con Öcalan, il gruppo sta lavorando per riunire i popoli curdi di tutte le principali regioni e paesi, nonché di diversi orientamenti politici e strategici. I suoi membri hanno rilasciato una dichiarazione ampia e coraggiosa durante la cerimonia alla grotta di Jasana, l’unica comunicazione consentita quel giorno.
Il gruppo ha sottolineato che l’atto di “distruggere volontariamente le nostre armi, davanti a voi” è stato considerato “un gesto di buona volontà e determinazione”. Hanno affermato di averlo fatto in conformità con la dichiarazione di Öcalan, nella convinzione di non credere “nelle armi” ma nel potere del popolo. Hanno affermato che il loro atto di disarmo è stato compiuto “con grande orgoglio e onore nel fare ciò che è necessario per questo principio storico”.
La dichiarazione è stata letta ad alta voce in modo drammatico in curdo da Besê Hozat, copresidente del Consiglio esecutivo dell’Unione delle comunità del Kurdistan e attiva sostenitrice del femminismo e della leadership femminile. È stata letta anche in turco e distribuita in inglese e in altre lingue a tutti i presenti. “Data la crescente pressione fascista e lo sfruttamento in tutto il mondo e l’attuale bagno di sangue in Medio Oriente”, si legge nella dichiarazione, “il nostro popolo ha più che mai bisogno di una vita pacifica, libera, equa e democratica”.
Sebbene rimangano ancora alcune questioni aperte su come contribuire a soddisfare queste esigenze a livello locale, è probabile che i cambiamenti avverranno attraverso progetti e campagne in materia di istruzione, assistenza sanitaria, alfabetizzazione, emancipazione delle donne e apprendimento delle pratiche democratiche. Programmi di questo tipo hanno già avuto molto successo nelle comunità curde della Siria, nell’area che è diventata nota come Rojava.
Al di là del significato di queste parole e azioni per il popolo del Kurdistan, della Turchia, dell’Iraq e della Siria, la lotta per la libertà dei curdi e le sue attuali iniziative segnalano sfide vitali per i movimenti di resistenza globali ovunque. Ecco tre elementi del movimento curdo che sono stati fondamentali per la sua popolarità e il suo successo e che potrebbero essere di beneficio alle forze progressiste di tutto il mondo.
1. La centralità delle donne in tutti i settori della lotta
Molto più che un semplice fenomeno locale isolato, il movimento di resistenza del Rojava è da tempo un esempio di esercizio dei diritti delle donne anche in mezzo a una guerra attiva e a pratiche patriarcali profonde. Per alcuni analisti e attivisti che hanno fatto parte o studiato il Rojava, la regione curda della Siria contemporanea – controllata dall’Amministrazione Autonoma Democratica del Nord e dell’Est della Siria, o DAANES – ha la maggiore parità di genere di qualsiasi governo al mondo.
In un recente articolo della femminista e ambientalista britannica Natasha Walter, lo slogan che afferma la vita “Donne, Vita, Libertà” è presentato non solo come un grido di battaglia retorico, ma come una celebrazione dei cambiamenti in atto anche al di là delle comunità curde che hanno coniato la frase. Durante le ricerche per un libro sui movimenti di resistenza femminista, Walter è giunta a una conclusione chiara sulle donne della DAANES e delle diverse comunità curde: “Queste donne sono probabilmente le femministe più determinate che abbia mai incontrato”.
Non è difficile capire dove alcune di queste idee abbiano preso forma. Anche in questo caso, il ruolo di Öcalan è importante. La sua affermazione secondo cui “un paese non può essere libero se le donne non sono libere” ha guidato la pratica in gran parte del Kurdistan per più di un decennio. In un opuscolo del 2013, “Liberating Life, Women’s Revolution” (Liberare la vita, la rivoluzione delle donne), ha scritto: “La misura in cui la società può essere trasformata radicalmente è determinata dalla misura della trasformazione raggiunta dalle donne. Allo stesso modo, il livello di libertà e uguaglianza delle donne determina la libertà e l’uguaglianza di tutti i settori della società”.
La trasformazione delle relazioni nella regione del Rojava è stata notata da molte femministe internazionaliste di spicco, tra cui l’accademica e attivista Meredith Tax. Lei ha scritto chiaramente che il Rojava e i movimenti curdi ad esso collegati erano “il posto migliore in Medio Oriente per essere una donna” e un esperimento attivo degno di studio e sostegno a livello globale.
2. La natura mutevole dello Stato-nazione
L’idea che gli “Stati” non debbano necessariamente essere il principale modo in cui le persone interagiscono tra loro non è esclusiva dei pensatori anarchici o del movimento curdo. Esempi di precedenti sfide ai modelli nazionalisti includono le Black Panthers e il movimento zapatista messicano. Sono passati molti decenni da quando i radicali potevano dare per scontato che tutte le grandi lotte fossero basate sulla liberazione nazionale. Con questo non si vuole dire che la centralità vitale della terra sia diminuita o che l’identità “nazionale” di una persona non sia importante.
Tuttavia, l’era delle lotte di liberazione nazionale basate sulla conquista di Stati nuovi o appena liberati è ormai tramontata da tempo. Anche i nuovi Stati nazionali progressisti che sono emersi, come ad esempio il Sud Sudan, sono nati più dalla mediazione e dal compromesso che da efficaci lotte di liberazione. L’introduzione curda del “confederalismo democratico” deve essere vista in questo contesto più ampio. Gli ideali insiti nel confederalismo democratico includono la democrazia diretta, l’autonomia, l’ecologia politica, il femminismo, il multiculturalismo, l’autodifesa, l’autogoverno e le economie cooperative.
Anche in questo caso, il lavoro e le parole di Besê Hozat sono istruttivi. Commentando l’azione dell’11 luglio, ha osservato che i guerriglieri curdi che hanno deposto le armi non volevano semplicemente scendere dalle montagne e deporre le armi. “Vogliamo diventare pionieri della politica democratica”, ha osservato, “ad Amed, Ankara e Istanbul”. Il potere politico, l’autonomia e la democrazia, secondo l’analisi di Hozat e di molti esponenti del movimento curdo, non significano che vogliano costruire un nuovo Stato-nazione.
“Un sistema statale non sarebbe vantaggioso per il popolo curdo, ma una spina nel fianco”, ha dichiarato a New Internationalist nel 2017.
“Approfondirebbe la lotta con i nostri vicini e porterebbe decenni di guerra contro gli arabi, oltre che caos e sofferenza”.
Con il popolo curdo sparso in almeno quattro nazioni esistenti (alcune in forte conflitto tra loro), l’idea di attraversare i confini esistenti per riunire comunità separate artificialmente sembra particolarmente allettante, e non solo nel contesto curdo. Il superamento dei confini e delle frontiere attuali è stato discusso in circoli panafricanisti, delle isole del Pacifico e in altri circoli decolonizzatori. Tra questi vi è l’Occupied People’s Forum, che riunisce leader della resistenza ancora colonizzati provenienti dal Kurdistan/Rojava, dal Kashmir, dalla Palestina, da Porto Rico, dal Sahara occidentale, dalla Papua occidentale, dal Tibet e dall’Ambazonia.
Le iniziative strategiche e tattiche dei movimenti curdi che trascendono qualsiasi regione o singola struttura organizzativa curda sono istruttive per tutte queste lotte attive. Nel succinto quadro per il futuro delineato da Hozat: «L’era dello Stato-nazione è finita».
3. La dialettica della nonviolenza, della rivoluzione e della lotta armata
Ci sono poche prove storiche che suggeriscano che i principi pacifisti o una revisione scientifica delle ricerche sulla resistenza civile abbiano portato alla decisione curda. Piuttosto, il movimento curdo sta esplorando opzioni basate sulle esperienze e sulle condizioni odierne, guardando avanti per capire quali tattiche si adattino meglio al movimento e ai suoi popoli. Come ha affermato Hozat: «Per un movimento che invoca una politica democratica, le armi sono ora un ostacolo. Vogliamo rimuovere questi ostacoli con serietà e responsabilità».
Il Gruppo per la Pace e la Democrazia e la leadership del movimento curdo non sono certo i primi a concludere che sono necessarie nuove metodologie per le nuove condizioni che stanno affrontando.
Nel 2018, il Fronte Polisario del Sahara Occidentale ha contribuito a coordinare la conferenza Sahara Rise, che ha riunito diversi settori della società saharawi per esaminare e orientare le loro politiche verso la resistenza civile nonviolenta.
Dopo decenni di resistenza multiforme che si è orientata fortemente verso la guerriglia urbana, i militanti portoricani associati ai movimenti armati sono diventati più aperti al potere strategico dell’azione diretta nonviolenta e della disobbedienza civile. Nelle parole dell’ex prigioniera politica portoricana Alejandrina Torres, “Ogni periodo storico attraversa delle fasi, e noi dobbiamo crescere e svilupparci in risposta ai tempi”.
L’iniziativa del gruppo curdo contemporaneo è diversa solo per intensità e precisione pragmatica. Ha iniziato questa nuova fase con una serie di conversazioni e azioni diffuse che guardano con attenzione al futuro. In una valutazione dell’autrice e attivista olandese Fréderike Geerdink, l’atto unilaterale di cessate il fuoco del 2025 è ben lungi dall’essere un segno di resa, sconfitta o debolezza, ma semplicemente il riconoscimento che lottare per la libertà con le armi militari “non è più ‘logico’” nel periodo attuale.
Affinché questo esperimento con mezzi non violenti funzioni al meglio, il movimento curdo spera che le sue azioni per “una pace onorevole” non siano un’iniziativa unilaterale. Qualunque sia la risposta delle forze avversarie, le azioni di luglio si sono intraprese in risposta a una valutazione delle esigenze della popolazione. Come ha affermato l’attivista curda Nilüfer Koç, portavoce della Commissione per le relazioni estere del Congresso nazionale curdo:
“Dobbiamo andare avanti con speranza”.
Gli atti di disarmo diretto dell’11 luglio nella regione montuosa del Kurdistan iracheno danno concrete ragioni di nuova speranza al popolo curdo e a tutti noi.
*Fonte: Waging Nonviolence, 15 luglio 2025
Traduzione di Enzo Gargano per il Centro Studi Sereno Regis