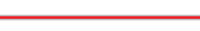lavialibera. Le città invisibili, 6 luglio 2025, di Davide Grasso
Il 12 maggio scorso il Partito dei lavoratori del Kurdistan, uno dei più grandi e longevi movimenti rivoluzionari del mondo, ha annunciato la dissoluzione. Una scelta frutto di una lunga riflessione: dalle critiche ai modelli patriarcali ed ecocidi, passando attraverso l’esperienza rivoluzionaria di Kobane, fino alla fallita insurrezione armata in Turchia. L’analisi di Davide Grasso
Viviamo una fase di violenta ridefinizione degli equilibri storici, normativi e dei rapporti di forza globali. Assistiamo, come ha scritto la Campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele (Pacbi), al primo genocidio trasmesso in diretta della storia, quello palestinese a Gaza. I massacri russi in Ucraina e le aggressioni israeliane al Libano, alla Siria e all’Iran segnano lo sprofondare del mondo in un secolo di guerra avviato dalle politiche belliche unilaterali statunitensi degli anni Novanta (Serbia), Duemila (Iraq) e dalla ventennale occupazione dell’Afghanistan.
In questo contesto mondiale il 12 maggio scorso l’annuncio della dissoluzione e del disarmo del Partito dei lavoratori del Kurdistan o Pkk – uno dei più grandi e longevi movimenti rivoluzionari di guerriglia nel mondo – ha colto di sorpresa se non deluso molti, a partire da coloro che si erano abituati a considerare questo movimento una delle poche certezze, o un punto di riferimento teorico e politico in un panorama internazionale e postcoloniale dove le forze socialiste appaiono al momento residuali. Per comprendere le ragioni, e soprattutto il senso, della scelta annunciata dal Pkk, occorre considerare tanto le evoluzioni storiche quanto quelle ideologiche di questo movimento.
La comprensibile ostilità dello Stato turco ha invece indotto le nazioni della Nato a bollare l’organizzazione come terrorista. La Corte di giustizia dell’Unione europea, tuttavia, ha sentenziato nel 2018 che l’Ue ha inserito il Pkk nella lista senza portare elementi empirici sufficienti a sostegno di questa decisione
Fondato nel 1978 dopo diversi anni di attivismo studentesco nelle università turche da parte di universitari di lingua madre curda e turca, il Pkk è il più recente dei partiti comunisti al mondo a diventare forza trainante ed egemone nella propria nazione. È stato inoltre uno dei pochi partiti marxisti-leninisti ad assumere un ruolo di peso e durata in una nazione extra-europea abitata da una maggioranza musulmana. Benché vi siano stati altri partiti comunisti di rilievo nel mondo musulmano, a partire dalla Palestina, nella nazione (anch’essa senza stato) del Kurdistan (che conta quasi quaranta milioni di persone di idiomi di derivazione indo-iranica tra Iran, Armenia, Turchia, Siria e Iraq) il Pkk ha saputo in tempi brevissimi incarnare una nuova lotta di liberazione.
La creazione del Pkk e la sua decisione di avviare un’insurrezione armata contro lo Stato turco nel 1984 hanno portato la comunità internazionale a dividersi sulla sua natura: legittimo movimento di liberazione nazionale o organizzazione terroristica? L’Onu non ha mai inserito il Pkk nella lista delle organizzazioni terroristiche, peraltro compilata senza che vi sia una giurisprudenza coerente su questo tema. Sulla stessa linea si è schierata la quasi totalità della comunità internazionale, e tra gli altri Russia, Cina, Iran, Egitto, Brasile e il Sudafrica dopo la liberazione dall’Apartheid. La comprensibile ostilità dello stato turco ha invece indotto le nazioni della Nato (di cui la Turchia è unico membro nel mondo musulmano) a bollare l’organizzazione come terrorista. La Corte di giustizia dell’Unione europea, tuttavia, ha sentenziato nel 2018 che l’Ue ha inserito il Pkk nella lista senza portare elementi empirici sufficienti a sostegno di questa decisione. La sentenza ha mostrato, come le vicende legate alla guerra in Siria, che anche le istituzioni legate alla Nato sono divise su questo punto.
L’affermazione del Pkk
Secondo il Pkk il Kurdistan era una colonia della Turchia anche a causa del tradimento nazionale della classe latifondista curda, che per poter sfruttare contadini e lavoratori ha accettato la sovranità di elite turche o arabe imposte dalle potenze europee
La rapidità con cui il Pkk si è imposto tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta sulla scena politica curda è dovuto all’originalità della sua impostazione teorica: secondo il Pkk il Kurdistan non era una regione o parte, ma una colonia della Turchia, e questa dominazione coloniale era possibile anche a causa del tradimento nazionale della classe latifondista curda, che per poter sfruttare contadini e lavoratori ha accettato la sovranità di elite turche o arabe imposte sul Kurdistan dalle potenze europee tra gli accordi di Sykes-Pikot (1916) e il Trattato di Losanna (1923). I militanti del Pkk hanno per questo iniziato già negli anni Settanta una violenta lotta contro le elite curde locali. Questo ha attratto l’adesione di migliaia di giovani contadini. La collocazione comunista e decoloniale del Pkk ha portato inoltre, nel 1979, a un’intesa con il Fronte democratico di liberazione della Palestina a Damasco, che ha propiziato la decisiva apertura di campi di addestramento per il Pkk in Libano (con il benestare di Assad padre in Siria).
Ne è seguita la guerra di guerriglia: prima contro Israele nel paese dei cedri, durante l’invasione del 1982, quindi contro la Turchia della dittatura militare dal 1984. Il carattere tardivo dell’affermazione di questo movimento ne ha fatto un paradosso storico che dura tuttora: all’apice della forza e del sostegno sociale per il Pkk durante la serihildan (sinonimo di Intifadah in curdo) dei primi anni Novanta, il mondo comunista si dissolveva, le forze palestinesi accettavano gli accordi di Oslo mettendo fine alla prima intifadah, l’influenza del marxismo sulle elite intellettuali mediorientali o occidentali si incrinava, gli Stati Uniti riposizionavano le proprie truppe dall’Europa al mondo musulmano con la scusa del debito di guerra iracheno. In questo contesto il Pkk ha avviato una riflessione collettiva ed è diventato l’unico movimento comunista di massa ad aver messo a punto un pensiero e una strategia per rinnovare in profondità i paradigmi della lotta nel contesto successivo sia al 1989 che alla crisi dei movimenti secolari di decolonizzazione. Questa svolta, elemento importante, è stata spronata da una rivolta femminile interna al partito, che ne ha messo in discussione la mentalità patriarcale.
Il Pkk ha ripensato i paradigmi rivoluzionari
Tanto il comunismo quanto la decolonizzazione, secondo il Pkk di fine anni Novanta, avevano raggiunto risultati fondamentali, ma erano rimasti intrappolati nel modernismo divenuto estrattivo, ecocida e genocida
Non sarebbe possibile comprendere la logica del processo di trasformazione di questi mesi senza tenere a mente questi passaggi di lungo periodo. A cavallo del nuovo millennio, tanto prima quanto dopo l’arresto del presidente del partito, Abdullah Öcalan, il Pkk non soltanto ha avviato diversi tentativi di dialogo e coesistenza con lo Stato turco (dal 1993 al 2015), ma ha proposto un’autocritica del movimento comunista nel quadro dell’autocritica generale, considerata necessaria, del paradigma socialista. Essa doveva interessare le pratiche dei movimenti di liberazione europei ed extra-europei, dalla rivoluzione francese all’insurrezione curda, passando per l’Ottobre rosso e la rivoluzione culturale cinese. Tanto il comunismo quanto la decolonizzazione, secondo il Pkk di fine anni Novanta, avevano raggiunto risultati fondamentali, animati da fini giusti e intenzioni cristalline, ma erano rimasti intrappolati in una logica figlia (fin dal XVIII e XIX secolo) del modernismo divenuto estrattivo, ecocida e genocida della modernità capitalista.
Si tratta di una linea di decostruzione che ha punti in comune con la critica della colonialità portata avanti in America Latina, in ambiti più accademici, negli stessi anni. L’idea di rivoluzione mutuata dalla rivoluzione francese era stata – da Parigi a Saigon passando per L’Avana o San Pietroburgo – quella di un’imposizione della logica statale alla società, di una fiducia comprensibile ma a conti fatti ingenua nello “sviluppo” economico e tecnologico, e una sottovalutazione della profondità della penetrazione della mentalità coloniale nella modernità, anche quando declinata in senso socialista e nazionale; una concezione verticale della rivoluzione come ingegneria sociale dall’alto verso il basso che si è nutrita di un sostanziale disprezzo per le tradizioni, i costumi, le identità e le emozioni di coloro che di questa modernità sono relegati a soggetti da dominare, sfruttare e colonizzare.
Il colonialismo sarebbe per il Pkk il portato, tuttavia, di una storia del dominio che non inizia con il capitalismo globalizzato e finanziario battezzato dal Rinascimento europeo. L’era in cui gli dei si mascherano da Stati-nazione di matrice europea, legittimando giuridicamente la presa sull’ambiente e sul genere umano dell’assoggettamento gerarchico sotto forma di capitale, è l’ultimo episodio di una storia complessiva delle civiltà, che offre una varietà non meno problematica di forme di colonialità patriarcale, classista e imperiale. Queste ultime, prone a una logica di asservimento, guerra e colonizzazione di identità sottomesse nel corso (almeno) degli ultimi cinquemila anni, sono l’effetto della prima e più profonda colonizzazione, che si potrebbe definire originaria: quella del corpo e del lavoro delle donne da parte di noi uomini.
Questa riflessione è stata fatta propria anche da nuovi partiti nati nella società curda: il Partito della democrazia e dell’uguaglianza tra i popoli (Dem Parti) in Turchia, il Partito di unione democratica in Siria, il Partito della vita libera in Iran. Non si tratta di forze marginali in termini di peso socio-politico (come spesso sono in questa fase quelle post-comuniste occidentali o arabe), ma rilevanti al punto da mobilitare masse elettorali, migliaia di quadri politici e militanti armati. Le forze del nuovo paradigma in Turchia sono diventate terzo partito del paese, quelle in Siria hanno promosso una rivoluzione nel nord-est, quelle in Iran hanno agito da protagoniste nei movimenti per il cambiamento nel paese e proposto a giugno una terza via rispetto al bivio, giudicato soltanto apparente, tra sostegno alla guerra israeliana o al regime islamico. Lo slogan “Jin, jiyan, azadi” (donna, vita, libertà) è conio dei movimenti delle donne nati da questo “nuovo paradigma”.
Il modello Kobane e l’influsso sulla Turchia
Lo sviluppo di questi partiti, movimenti e rivoluzioni ha trasformato profondamente il panorama politico del Kurdistan, producendo un insieme di attori che hanno prodotto percorsi talvolta diversi. Il successo del nuovo paradigma in Siria, ad esempio, ha portato nel 2014 al grande afflusso di giovani curde e curdi nella resistenza di Kobane attaccata da Daesh (o Isis). L’idea non era prendere il potere in Siria, ma costruire forze economiche e politiche dal basso che contendessero allo stato il potere assoluto sull’insieme del territorio. La rivoluzione confederale punta infatti a una relativizzazione e a un indebolimento tendenziale delle pretese storiche dello Stato-nazione postcoloniale, non alla sua distruzione. Si tratta di una concezione originale della trasformazione come della democrazia, che in questa logica non è principalmente un modello decisionale rappresentativo, ma un modo democratico di vivere e produrre insieme.
A Kobane, per la prima volta, l’intero mondo arabo e quello occidentale hanno preso atto – talvolta attraverso lenti problematiche e variamente razziste – dell’esistenza e della forza di questo movimento transnazionale, molto diverso ideologicamente dagli altri attori delle insurrezioni e resistenze regionali, ma anche dai tradizionali movimenti comunisti. Il successo della resistenza di Kobane ha provocato un terremoto politico in tutto il Kurdistan, con effetti di rilievo in Siria e Turchia. Gran parte delle formazioni dell’Esercito libero siriano che combattevano Assad si sono alleate alle Ypg-Ypj curde formando le Forze siriane democratiche. Il Dem Parti (all’epoca Hdp) ha assunto un peso inedito per una formazione socialista in Turchia, distinta tanto dall’opzione nazionalista quanto da quella islamista. Esso raduna esperienze socialiste e comuniste di varie aree del paese e non solo delle regioni curde. Superando stabilmente, da dieci anni, lo sbarramento del 10% per entrare in parlamento, ha modificato lo scenario istituzionale turco.
L’insurrezione armata del Pkk e la repressione
Nel 2015 si è aperta per il Pkk l’opportunità per promuovere un’insurrezione armata in Turchia, che è stata repressa duramente da Ankara. Molte popolazioni delle aree interessate non ha compreso perché il Pkk l’abbia fatto senza avere i mezzi adeguati
Quando questo processo politico si è manifestato, nel 2015, il Pkk ha ritenuto si fosse aperta una finestra di opportunità per promuovere un’insurrezione armata in Turchia, arrivando fino ai centri urbani del sud-est e nelle periferie di Istanbul. Questa insurrezione è durata mesi ma è stata duramente repressa dallo Stato, che ha attuato una punizione collettiva delle regioni coinvolte radendo al suolo interi quartieri, sommergendo con le dighe reperti archeologici, distruggendo moschee, vie e quartieri: la memoria tangibile e intangibile dei luoghi più importanti per l’eredità culturale curda. Oltre all’uccisione o all’arresto di migliaia di persone, questo ha significato la costruzione di nuovi quartieri secondo i canoni impersonali e le logiche speculative di quella che il Pkk considera la declinazione capitalista dell’idea di modernità.
Questi fatti hanno lasciato un trauma che è fondamentale, io credo, tenere presente in rapporto alla recente scelta del Pkk di sciogliersi. Gran parte della popolazione di quelle regioni non ha compreso allora, e non comprende oggi, perché il movimento ha lanciato un’insurrezione senza avere i mezzi materiali per arginare la reazione statale (di fronte a distruzioni e massacri ancora più gravi, è verosimile che questo confronto abbia presto luogo anche in seno al movimento di liberazione palestinese). Per comprendere questo fenomeno sul piano sociologico è utile considerare che la maggior parte dei militanti del Pkk ha vissuto sulle montagne turche e soprattutto irachene in questi anni, sottoposta a pesanti bombardamenti. Gli attivisti urbani delle regioni curde di Turchia, o gli stessi quadri dirigenti del Rojava, sono stati visti da alcuni di loro, in questo contesto, come “privilegiati” adagiatisi in una narrazione riformista che esclude il necessario, per quanto difficile, scontro diretto con gli apparati statali.
Non sono pochi, in effetti, i quadri politici del Dem Parti, pur vicino ideologicamente al Pkk, che nel 2015 non condivisero la scelta dell’insurrezione armata, soprattutto nelle città. Quale conseguenza della repressione, in questi dieci anni una cappa repressiva ha bloccato la primavera che aveva preceduto e seguito Kobane. Tra i militanti del Pkk (talvolta accusati di non voler ascoltare i dubbi e le perplessità emerse nelle organizzazioni civili) e le organizzazioni legali e sociali si è sviluppato così un certo divario nel contesto curdo di Turchia, che molte e molti testimoni hanno confermato in questi anni.
Un Pkk marginalizzato potrebbe rallentare la trasformazione
La lotta armata in Turchia e Iraq è apparsa tanto più senza sbocchi perché, contrariamente alla guerra rivoluzionaria condotta in Siria, non lasciava intravedere ormai una fine prevedibile e un obiettivo chiaro
Il problema è che il “nuovo paradigma” proposto da Öcalan prevede proprio che la logica contrappositiva con lo Stato – considerata figlia, paradossalmente, proprio della mentalità statale, binaria ma non “dialettica” – sia abbandonata. Al suo posto viene proposta la costruzione di un’alternativa sociale al modo statale di organizzare le relazioni sociali, che mantenga la sua autonomia tanto nelle fasi di autodifesa quanto in quelle in cui la storia presenta l’opportunità di forme di coesistenza con gli ordinamenti statali. Öcalan, coinvolto dal 2024 in un processo di dialogo con lo Stato che ha visto protagonista in primo luogo il Dem Parti, ha allora lanciato la sfida più alta al Pkk, chiedendo di porre fine a una guerra di dieci anni (la più lunga nella storia del partito) e, infine, di una storia di 47 anni.
Il cuore delle politiche rivoluzionarie ispirate al nuovo paradigma del Pkk sono state in questi dieci anni, del resto, non in Turchia ma in Siria, dove il Partito di unione democratica ha scelto una strada che il Pkk ha sempre considerato (sia pur positivamente) come riformista. La lotta armata in Turchia e Iraq è apparsa tanto più senza sbocchi perché, contrariamente alla guerra rivoluzionaria condotta in Siria, non lasciava intravedere ormai una fine prevedibile e un obiettivo chiaro. Gli ultimi dieci anni hanno nei fatti portato il nucleo originario del pensiero socialista curdo, il Pkk, a rischiare di essere marginalizzato dalle nuove forme di organizzazione e teoria del mutamento che quel partito stesso ha contribuito a produrre. La scelta del congresso tenuto dal partito il 5-7 maggio, dove sono stati decretati il disarmo e lo scioglimento – secondo modalità tutte da definire – ha nei fatti preso atto che una certa struttura politico-militare rischierebbe di essere involontario intralcio ai processi di lotta o negoziato in corso in Siria come in Turchia.
A questo si riferisce il documento inviato da Öcalan al congresso, dove il presidente parla della necessità di compiere un ulteriore passo nella trasformazione della personalità limitante, lasciandosi alle spalle i residui di mentalità patriarcale e statale ereditati dal socialismo reale. Resta il fatto che gran parte di ciò che fa da sfondo allo scioglimento annunciato del Pkk è opaco, parte di trattative sostanzialmente segrete in Turchia e solo in parte pubbliche in Siria. Molto di ciò che alberga nelle menti delle dirigenze delle destre turche, soprattutto, non è chiaro. Prima ancora di fare affermazioni audaci su processi che sono tenuti lontani dallo sguardo delle opinioni pubbliche, è bene comprendere le premesse politiche soggettive di quanto sta accadendo.
Il Pkk ha creato un paradigma nuovo, che propone una rottura con il modello rivoluzionario tradizionale. Questo paradigma ha prodotto risultati: rivoluzioni e cambiamenti, nuove istituzioni, sconvolgimenti politici nella regione, nuovi soggetti collettivi organizzati dotati di una certa forza. In uno scenario profondamente trasformato da questi soggetti e processi, il Pkk ritiene di aver esaurito la sua missione. Per questo ha annunciato, nel suo documento congressuale, una nuova fase per un movimento di liberazione che si è originato nel Kurdistan, ma che ormai, in buona parte, lo trascende.