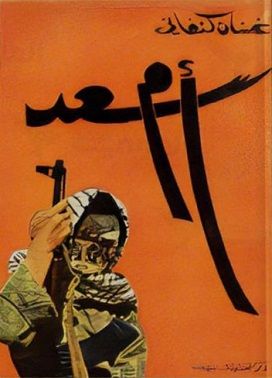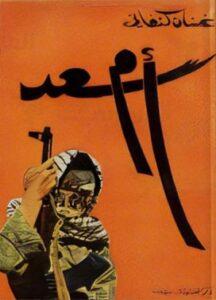Afghanistan, quattro anni d’impunità e persecuzione di genere
agoravox.it Riccardo Noury – Amnesty International (sito) 9 ottobre 2025
In occasione del quarto anniversario della presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan, Amnesty International ha sollecitato le autorità di fatto talebane a porre immediatamente fine all’amministrazione arbitraria e iniqua della giustizia, ripristinando un quadro costituzionale e giuridico formale e lo stato di diritto, in conformità agli obblighi dello stato ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani.

Da quando nell’agosto 2021 i talebani hanno riassunto il potere, l’intero sistema giuridico afgano è stato smantellato e sostituito da un assetto normativo basato sulla religione, plasmato secondo un’interpretazione estremamente rigida della legge islamica (shari’a): un sistema segnato da profonde incoerenze, impunità dilagante, processi arbitrari e segreti nonché punizioni inflitte sulla base di pregiudizi personali, comprese frustate in pubblico, maltrattamenti e torture.
Prima dell’agosto 2021 la legislazione afgana si basava su una Costituzione scritta e veniva adottata da organi parlamentari elettivi, grazie ad alcune riforme avviate nel 2001 che avevano portato a diversi miglioramenti. I tribunali operavano su più livelli (tribunali di primo grado, d’appello e corte suprema) e si avvalevano di pubblici ministeri indipendenti e di strutture autonome per la difesa legale. Le sentenze erano in genere documentate, soggette ad appello e sottoposte a controllo pubblico.
Sotto il controllo dei talebani, i procedimenti giudiziari si svolgono generalmente davanti a un singolo giudice, affiancato da un esperto di diritto religioso che esprime pareri sull’emissione di verdetti religiosi sulla base dell’interpretazione personale dei testi sacri.
Un ex giudice ha spiegato ad Amnesty International le forti discrepanze nelle sentenze, dovute al ricorso a diverse scuole di pensiero islamico e orientamenti giuridici:
“In alcune zone le decisioni si basano sul manuale Bada’i al-Sana’i, mentre in altre si fa riferimento al Fatawa-i Qazi Khan. Lo stesso reato può portare a verdetti completamente differenti”.
Per un’accusa come il furto le sanzioni possono variare dalle frustate pubbliche alla detenzione di breve durata, a seconda delle interpretazioni individuali.
Un ex pubblico ministero ha riferito che in alcuni tribunali rurali i giudici venivano visti consultare testi religiosi durante i processi alla ricerca di riferimenti ritenuti adeguati, con conseguenti lunghi ritardi e risultati incoerenti. L’assenza di leggi nazionali codificate ha privato le persone, tanto quelle che amministrano la giustizia quanto quelle che l’affrontano, di qualsiasi certezza e chiarezza.
Prima della presa del potere da parte dei talebani, le donne ricoprivano attivamente il ruolo di giudice, magistrata e avvocata. Rappresentavano tra l’otto e il dieci per cento della magistratura e quasi 1500 erano registrate come avvocate e consulenti legali presso l’Ordine indipendente degli avvocati dell’Afghanistan, circa un quarto della sua intera composizione. Oggi la maggior parte di loro è costretta a nascondersi o è fuggita, dopo essere stata allontanata dal proprio incarico in seguito all’ascesa al potere dei talebani.
Le istituzioni che un tempo offrivano tutela ai diritti delle donne, come i tribunali per la famiglia o i dipartimenti di giustizia minorile e contro la violenza sulle donne, sono state smantellate, lasciando le donne prive di un reale accesso alla giustizia e a rimedi effettivi.
“Nei tribunali dei talebani la voce di una donna non viene ascoltata, non perché non abbia nulla da dire ma perché non è rimasto nessuno disposto ad ascoltarla”, ha commentato un ex giudice.