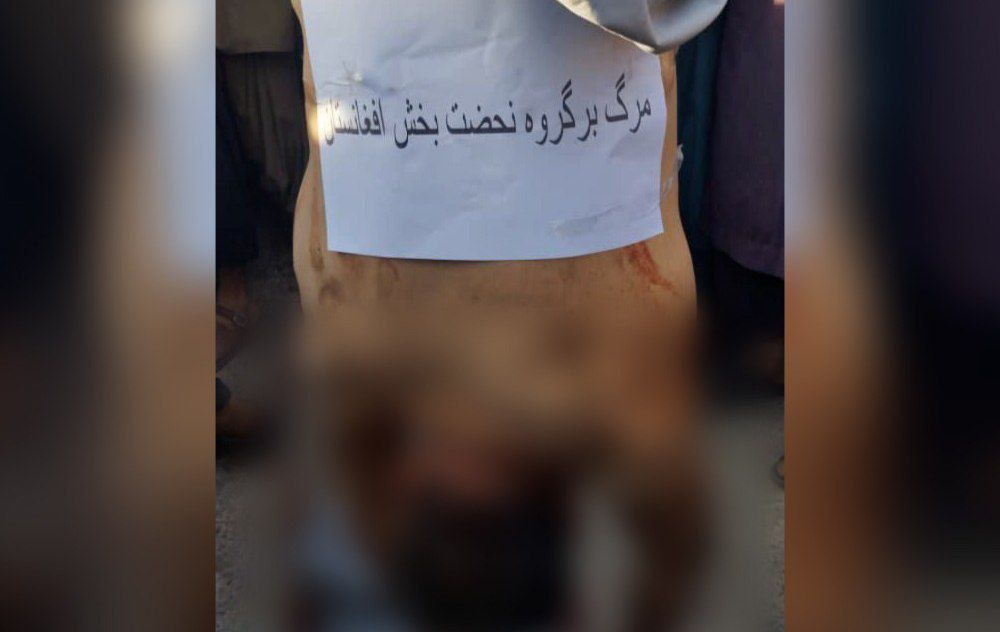Shams Rahman, Zan Times, 5 settembre 2025
Nelle case distrutte del villaggio di Wadeer, nella provincia afghana di Kunar, i sopravvissuti al devastante terremoto di domenica, che ha ucciso più di 2.200 persone, affermano di essere ancora in attesa degli aiuti più basilari: cibo e riparo.
Il terremoto di magnitudo 6.0, che ha colpito l’Afghanistan orientale verso mezzanotte, ha causato oltre 3.600 feriti, secondo i funzionari talebani. E in tutta la provincia di Kunar, oltre 5.700 case sono state distrutte. Il distretto di Nurgal, nella parte occidentale della provincia di Kunar, dove si trova il villaggio di Wadeer, è stato l’epicentro della devastazione, con 1.000 morti confermati e 2.500 feriti.
I talebani, che hanno preso il controllo del Paese nel 2021, hanno esortato enti di beneficenza, imprenditori e cittadini comuni a contribuire alla loro risposta. I portavoce talebani hanno diffuso online i numeri di conto bancario, con la promessa che le donazioni sarebbero state gestite con “trasparenza”.
Le difficoltà del soccorso
Un portavoce del governo talebano, Zabihullah Mujahid, afferma che le operazioni di soccorso continuano. Nelle zone irraggiungibili con gli elicotteri, sarebbero state paracadutate unità di commando per trasportare i feriti in salvo.
Ma sul campo, il divario tra annunci e azioni concrete si sta ampliando. Alcune squadre di soccorso volontarie hanno raggiunto il villaggio di Wadeer e sono state inviate unità sanitarie mobili, ma i residenti affermano che il supporto rimane insufficiente.
I danni alle strade causati dal terremoto e dalle recenti piogge hanno reso l’accesso ancora più difficile. In altri villaggi, alcuni sopravvissuti stanno ancora aspettando di estrarre i corpi dei loro cari dalle macerie.
“Abbiamo urgente bisogno di tende e cibo. Le persone hanno perso la casa; non hanno nemmeno i mezzi per cucinare. E abbiamo bisogno di più medici. Le équipe mediche sono troppo poche e le persone vengono ancora sepolte”, racconta al Guardian un anziano del villaggio di Wadeer.
“Siamo ancora seduti al sole perché non c’è una tenda”, dice una nonna di Wadeer, che è con i suoi due nipoti. “Se ci fosse una tenda, potrei almeno tenerli all’ombra”.
Racconta che sua nuora e suo marito sono stati portati in ospedale in elicottero, ma non ha idea di dove. Nessuno è tornato con informazioni o aiuti.
Lì vicino, un’altra donna che ha perso più di 30 parenti racconta: “Ho perso mio marito, i miei figli, i miei nipoti. Tutto. Mi è rimasto solo questo panno. Non ho nemmeno i soldi per comprare un paracetamolo”.
Le agenzie umanitarie hanno affermato che le donne sopravvissute al terremoto non possono accedere facilmente a soccorsi o supporto medico e che nelle province conservatrici come Kunar è difficile per una donna single chiedere aiuto a uomini non imparentati. L’autonomia e la libertà di movimento delle donne sono fortemente limitate dal regime talebano, incluso il divieto di parlare in pubblico.
Un solo ospedale funzionante
Nonostante sia uno dei distretti più colpiti, Nurgal ha un solo ospedale funzionante, che non riesce a gestire l’enorme numero di vittime. La maggior parte delle persone soccorse finora viene trasferita nella capitale afghana, Kabul, o nella vicina provincia di Nangarhar in elicottero per le cure.
Le organizzazioni internazionali hanno difficoltà a intensificare gli sforzi di soccorso, non solo a causa della conformazione del territorio, ma anche a causa delle gravi carenze di finanziamenti, molte delle quali derivano dal crollo più ampio del sostegno dei donatori all’Afghanistan.
“La situazione sul campo è critica”, afferma il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC). “Intere comunità hanno urgente bisogno di assistenza salvavita. Le risorse locali sono al limite e la mancanza di finanziamenti sta limitando la portata e la rapidità della risposta umanitaria”.
L’NRC afferma che le famiglie nella provincia di Kunar dormono in tende sovraffollate, alcune delle quali ospitano fino a 100 donne e bambini, senza accesso a servizi igienici o acqua pulita.
Da febbraio 2025, 422 centri sanitari in tutto l’Afghanistan hanno chiuso i battenti a seguito dei tagli agli aiuti statunitensi. Solo nell’Afghanistan orientale, 80 centri sanitari hanno chiuso i battenti, di cui almeno 15 a Kunar e 29 a Nangarhar, lasciando i sopravvissuti al terremoto ancora più vulnerabili.
L’NRC afferma che il suo portafoglio di finanziamenti è pari al 60% di quello del 2023, il che limita significativamente la sua capacità di rispondere alle crescenti esigenze umanitarie. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite, che aiuta gli sfollati in Afghanistan, afferma che i tagli ai finanziamenti di quest’anno hanno ridotto la capacità dei magazzini e la presenza dell’organizzazione sul campo, costringendo la maggior parte delle forniture a essere spedita da Kabul, il che aumenta ulteriormente i ritardi e i costi logistici.
Fondi stanziati, ma i soccorsi non arrivano
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre agenzie hanno dispiegato kit sanitari di emergenza, team mobili e ambulanze aggiuntive nella regione. Eppure, per molti nelle aree remote, l’accesso alle cure rimane impossibile. Con le strade bloccate e il numero insufficiente di elicotteri, gli abitanti dei villaggi devono aspettare, sperando che arrivino i soccorsi.
L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari afferma che 25 team inter agenzia hanno raggiunto alcuni distretti colpiti, ma ha ammesso che l’accesso alle valli più colpite rimane discontinuo e che le condizioni meteorologiche hanno ulteriormente ritardato i progressi.
Le Nazioni Unite hanno stanziato 10 milioni di dollari (7,4 milioni di sterline) in fondi di emergenza, 5 milioni dal Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze e altri 5 milioni dal Fondo Umanitario per l’Afghanistan. Ma i responsabili degli aiuti umanitari affermano che si tratta di una frazione di quanto necessario.
Per ora, in villaggi come Wadeer, le persone siedono sotto brandelli di stoffa o teli di plastica, piangendo i loro morti e temendo ciò che accadrà in futuro.
Kreshma Fakhri e Freshta Ghani hanno contribuito al reportage.
Questo rapporto è stato pubblicato in collaborazione con il Guardian .