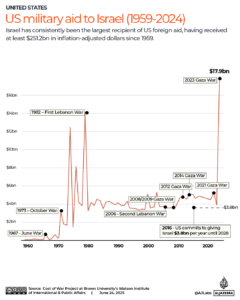Afghanistan: lo sport che non c’è, ma solo per le donne

Le Federazioni internazionali, il Comitato olimpico e le istituzioni internazionali non possono voltare le spalle né chiudere un occhio sulla sua violazione del diritto allo sport delle donne afghane
Carla Gagliardini, Bio Correndo, 1 luglio 2025
Se sentiamo la parola Afghanistan a cosa pensiamo immediatamente? Le risposte possono essere varie: è uno stato; è uno stato governato dai talebani; le donne vivono in una condizione di segregazione totale. Certamente ci saranno altre risposte ma queste saranno prevedibilmente quelle più frequenti.
Da qui possiamo partire per cercare di dare una descrizione sintetica dell’Afghanistan che ci aiuti a comprendere le difficoltà che le donne incontrano tutti i giorni, anche nell’esercitare il diritto a praticare lo sport. Il diritto allo sport è riconosciuto da diversi trattati internazionali ma è evidente che non ci voglia un documento, per quanto sia il frutto di una negoziazione ad alti livelli, per dare a un diritto umano il suo riconoscimento perché questo, proprio per la sua natura e qualità, è del tutto inscindibile dall’essere umano.
L’Afghanistan, i talebani e le donne
Iniziamo a collocare geograficamente l’Afghanistan che si trova nell’Asia meridionale e confina con il Tagikistan, l’Uzbekistan, il Turkmenistan, l’Iran, il Pakistan e la Cina.
Poi proviamo a descrivere sinteticamente chi siano i talebani, cioè coloro che governano l’Afghanistan. Secondo l’enciclopedia Treccani online i talebani sono un “gruppo di fondamentalisti islamici formatisi nelle scuole coraniche afghane e pakistane (dal pashtō ṭālib «studente»), impegnato nella guerriglia antisovietica in Afghanistan; tra il 1995 e il 1996 sono emersi come vincitori della guerra civile afgana successiva al ritiro dell’URSS e, conquistato il potere, hanno imposto un regime teocratico basato sulla rigida applicazione della legge coranica”[1].
Infine tentiamo di dire brevemente perché le donne vivono in una condizione di segregazione totale e lo facciamo con le parole di Minky Worden, direttrice del Global initiatives di Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa che da decenni monitora la violazione dei diritti umani nel mondo. Lo scorso 3 febbraio la Worden ha scritto nella lettera indirizzata a Jay Shah, presidente dell’International cricket Committee (ICC), che “dalla riconquista del potere nell’agosto del 2021, i talebani hanno imposto una lunga e crescente lista di regole e politiche che proibiscono alle donne e alle ragazze di esercitare i loro diritti fondamentali, includendo la libertà di espressione e di movimento, il diritto ad accedere a molti impieghi e il diritto all’istruzione oltre il sesto grado (scuole elementari, ndr). Ciò ha praticamente un impatto su tutti i loro diritti, incluso quello alla vita, ai mezzi di sostentamento, ad avere un luogo sicuro dove vivere, alla cura della salute, al cibo e all’acqua”.
Sport: “non necessario” per le donne
Poche settimane dopo il ritorno dei talebani alla guida dell’Afghanistan, avvenuto a metà agosto del 2021, il vice-capo della Commissione culturale dei talebani, Ahmadullah Wasiq, si diceva dubbioso sul futuro dello sport femminile nel paese, ritenendo la pratica sportiva non necessaria per le donne; parlando in particolare del cricket diceva che le ragazze “potrebbero trovarsi nella situazione in cui la loro faccia e il loro corpo non siano coperti. L’islam non permette che le donne siano viste in questa maniera. E’ l’era dei media e ci sarebbero foto e video che potrebbero essere visti dalle persone. L’islam e l’Emirato islamico (Afghanistan) non consentono alle donne di giocare a cricket o di praticare quegli sport che le vedano esposte”[2].
Intere squadre femminili hanno lasciato l’Afghanistan dall’agosto del 2021 con la speranza di poter continuare non solo a fare sport nei paesi di accoglienza ma anche di rappresentare la loro terra sotto la bandiera della nazionale afghana in esilio. Un messaggio politico che ovviamente non ha come unico destinatario il governo afghano poiché si chiede alle federazioni internazionali di non voltare lo sguardo.
La nazionale femminile di cricket che ha lasciato l’Afghanistan grazie al supporto di tre donne, Mel Jones (precedente giocatrice della nazionale australiana di cricket), Emma Staples e Catherine Ordway in collaborazione con il governo australiano, ha ripetutamente invitato l’ICC a intervenire per consentire alla squadra in esilio di giocare. Solo recentemente però è arrivata una risposta, probabilmente solo parziale, alle aspettative che le giovani avevano. L’ICC ha dichiarato di aver stanziato dei fondi per consentire alle atlete di proseguire nella pratica sportiva ma nulla ha fatto rispetto alla sanzione che dovrebbe raggiungere l’Afghanistan cricket board (ACB). Secondo le regole internazionali del cricket ogni federazione nazionale per poter essere membro di quella internazionale deve avere sia la squadra nazionale maschile sia quella femminile, per evidentemente tutelare e promuovere i diritti di tutti e di tutte a praticare questo sport. Dall’ingresso dei talebani al governo l’ACB non ha più la squadra femminile e questo dovrebbe essere sufficiente per cancellare dalle competizioni afghane quella maschile. Eppure …
Diritto negato di fatto anche dalla precedente Repubblica
Da un colloquio avuto con Sapeda, attivista afghana di cui per ragioni di sicurezza non è possibile rivelare il vero nome, è possibile disegnare il quadro afghano che riproduce la situazione dello sport femminile. Sostanzialmente si tratterebbe di una tela con uno sfondo dai colori cupi rappresentante l’oppressione di un governo che vuole dominare completamente la donna, oscurandola. Tuttavia da quelle tenebre si vedrebbero raggi di luce, quelli della resistenza di molte donne che, sfidando ogni sorta di pericolo e le conseguenze più spaventose, esercitano i loro diritti in modo clandestino, incluso quello di praticare lo sport.
Sapeda racconta che durante i vent’anni di occupazione dell’Afghanistan da parte della Coalizione guidata dagli Stati Uniti lo sport poteva essere praticato dalle donne nelle grandi città, nei villaggi la situazione era rimasta invece molto arretrata. Nei luoghi pubblici, come le palestre, l’accesso era suddiviso in fasce orarie per i due sessi, per impedire che uomini e donne potessero mescolarsi.
Alle donne e alle ragazze piaceva fare sport perché era un momento di socializzazione ma era anche un modo per riprendere la linea, soprattutto dopo tante gravidanze, e avere cura della propria salute.
Hambastagi, Partito afghano della solidarietà e unico partito laico, democratico, interetnico e indipendente esistente in Afghanistan[3], aveva aperto una palestra a Kabul dove si tenevano corsi di karate, di autodifesa e di ginnastica.
Le più giovani avevano un vivo interesse verso lo sport perché per loro poteva rappresentare una possibilità professionale. Infatti durante il periodo dell’occupazione si erano formate le squadre nazionali femminili in alcune discipline sportive e le atlete che ne facevano parte hanno avuto la possibilità di partecipare ai Giochi olimpici e a altre competizioni internazionali. Tuttavia non è stato sempre facile perché il governo afghano ha tentato molte volte di ostacolare l’invio delle nazionali femminili a tornei e gare fuori dai confini nazionali, sollevando ragioni di sicurezza derivanti dalle minacce dei talebani.
Sapeda dice che il governo di quel ventennio non proibiva la pratica sportiva alle ragazze e alle donne solo perché molte attività venivano gestite dalle Ong e ciò fruttava molti introiti che facevano gola.
Il diritto allo sport delle donne, unitamente a molti altri, non sono dunque mai stati al centro dell’attenzione dei governi talebani passati e presenti ma nemmeno di quelli che si sono insediati durante l’occupazione, la quale con la sua propaganda ha cercato di convincere il mondo che la guerra in Afghanistan era giusta, anche perché avrebbe liberato la donna. Non solo l’intento propagandistico non è riuscito, avendo continuato a lasciare oltre l’80% delle donne nella stessa condizione pre-occupazione, ma ha svelato tutta la sua inconsistenza quando nel momento del ritiro delle forze di occupazione le donne con i loro corpi, i loro sogni e la loro voglia di libertà sono state gettate nelle mani di estremisti fanatici che concepiscono in senso padronale il rapporto tra i due sessi.
Sport: diritto indiscutibile anche per le donne
Il Cisda, un’associazione italiana che dal 1999 aiuta e sostiene le donne afghane che vivono nel loro paese, ha ancora in corso la campagna “Stop fondamentalismi – Stop apartheid di genere”[4] che punta a far riconoscere nei trattati internazionali l’apartheid di genere come crimine contro l’umanità e chiede altresì che si riconosca il fatto che questo viene commesso sistematicamente e istituzionalmente in Afghanistan. Inoltre chiede che vengano attivate immediatamente le azioni necessarie da parte della Comunità internazionale per non legittimare i fondamentalisti che continuano a violare i diritti umani delle donne e gli obblighi legali internazionali dell’Afghanistan.
La negazione del diritto allo sport alle donne afghane ci ricorda ancora una volta che lo sport non è solo competizione ma è anche e soprattutto uno spazio della vita dove si costruiscono relazioni umane, dove ci si prende cura del proprio benessere psicologico e fisico. E’ il luogo dal quale si possono lanciare messaggi potenti, come fa da anni La corsa di Miguel. Ma è soprattutto un diritto indiscutibile che appartiene a uomini e donne nella stessa misura.
Le Federazioni internazionali, il Comitato olimpico e le istituzioni internazionali non possono voltare le spalle né chiudere un occhio sulla sua violazione se non vogliono far passare il messaggio che lo sport è sola competizione e, in quanto tale, viene trattato come un diritto esclusivo accessibile unicamente a chi ha dalla sua le risorse economiche, le strutture e il talento fino ad arrivare all’estremo di consentire che una legge possa vietare ad alcuni soggetti di praticarlo.
Note:
[1]Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/talebani/.
[2]https://www.bbc.com/news/world-asia-58571183.
[3]https://www.cisda.it/chi-sosteniamo/hambastagi/.
[4]https://www.cisda.it/campagne-e-petizioni/stop-fondamentalismi-stop-apartheid-di-genere/.
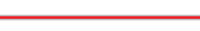




 La resilienza non è una scelta: per le donne, e per gli afghani in generale, è una necessità
La resilienza non è una scelta: per le donne, e per gli afghani in generale, è una necessità