Sotto il regime dei talebani, gli afghani LGBTQ+ affermano che la violenza sessuale e lo stupro sono all’ordine del giorno

NOTA: il presente rapporto contiene termini e dettagli che potrebbero risultare scomodi per alcuni lettori.
In una casa scarsamente illuminata alla periferia di Kabul, una donna transgender di 24 anni che ha chiesto di essere identificata come Remo è stata trattenuta per 28 giorni. Durante quel periodo, racconta di essere stata torturata e ripetutamente violentata dai combattenti talebani. Ha ottenuto il rilascio solo dopo aver promesso di continuare ad avere rapporti sessuali con il comandante che aveva ordinato la sua detenzione.
“Gli ho detto: ‘Non devi tenermi qui. Verrò quando vuoi'”, racconta Remo al Zan Times in un’intervista telefonica. “Nel momento in cui mi ha lasciato andare, sono scappato.”
La sua storia è solo una delle oltre dodici testimonianze dirette raccolte da Zan Times durante un’indagine durata 10 mesi, iniziata nel 2024, sul trattamento riservato dai talebani alle persone LGBTQ+. I risultati rivelano un modello inquietante e diffuso di violenza sessuale, tra cui lo stupro di gruppo, perpetrato contro le persone LGBTQ+ in Afghanistan. Le nostre conclusioni rispecchiano il recente rapporto di Richard Bennett, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan, pubblicato l’11 giugno.
“Le donne transgender sono particolarmente a rischio di violenza, tra cui stupro e violenza sessuale, durante l’arresto e la detenzione”, afferma il rapporto delle Nazioni Unite, aggiungendo: “Denunciare tali abusi è impensabile, poiché farlo esporrebbe la vittima, e potenzialmente le sue famiglie, a ulteriori violenze, vittimizzazione ed emarginazione sociale”.
Violentata in una “stanza degli interrogatori”
Nel dicembre 2021, i soldati talebani hanno fatto irruzione nell’appartamento di Ariana e del suo compagno a Kabul. Erano nudi in camera da letto quando i soldati talebani hanno iniziato a colpirli con calci di fucile e pugni. “Urlavano che eravamo sodomizzate e che meritavamo di essere uccise”, racconta Ariana, 25 anni, una donna transgender.
Le due sono state bendate e portate al distretto di polizia 8. Una settimana dopo, sono state trasferite nella prigione di Pol-e-Charkhi, dove Ariana afferma di essere stata ripetutamente violentata.
“Ogni due o tre notti mi portavano nella stanza degli interrogatori. Lì mi violentavano. A volte, da tre a quattro uomini”, racconta. “Filmavano tutto e lo mandavano ai loro amici, invitandoli a unirsi a loro.”
Questo schema di abusi rispecchia la testimonianza di Jannat Gul, una donna transgender detenuta per otto mesi dai talebani nella provincia di Herat, nell’Afghanistan occidentale. Secondo un rapporto congiunto pubblicato ad aprile da Rainbow Afghanistan, ILGA World e ILGA Asia, la donna è stata picchiata, sottoposta a scosse elettriche e stuprata di gruppo più volte a settimana.
“Mi hanno violentata con la forza. Ricordo che una notte, quattro di loro si sono alternati a violentarmi”, cita Gul nel rapporto.
Secondo il rapporto, i funzionari talebani hanno utilizzato strutture di detenzione formali e informali, comprese abitazioni private, per sottoporre persone LGBTQ+ a stupri, torture e degradazioni. In particolare, le donne transgender sono trattate come quelle che il rapporto definisce “schiave sessuali” e diverse sono scomparse dopo aver rifiutato richieste sessuali.
Sarwan, una donna transgender di 27 anni, racconta a Zan Times come i talebani l’abbiano portata al Distretto di Polizia 5 dopo un raid in casa sua. “Non c’era nessuna telecamera nella stanza. C’erano un bagno e un’altra stanza dove mi avrebbero portata per stuprarla, ma dicevano che era per l’interrogatorio”, spiega Sarwan. Dopo due notti di detenzione, la sua famiglia è riuscita a liberarla con l’aiuto degli anziani del posto.
Sarwan, Ariana e alcuni degli altri sopravvissuti intervistati da Zan Times affermano di essere stati pressati affinché rivelassero i nomi e gli indirizzi dei loro amici LGBTQ in cambio della loro libertà.
“I miei fratelli hanno deciso di uccidermi”
I talebani non sono gli unici autori di violenze anti-LGBTQ+ in Afghanistan. “Anche le persone LGBTQ+ subiscono discriminazioni e violenze all’interno delle loro famiglie e comunità”, afferma il rapporto di Bennett.
Darya, una persona transgender di Kabul, è stata arrestata per aver indossato pantaloni nel giugno 2024. “Un soldato talebano mi ha afferrato il telefono e, quando ho opposto resistenza, me l’ha rotto”, racconta. L’hanno picchiata selvaggiamente e portata al Distretto di Polizia 2, dove l’hanno gettata in una stanza buia senza bagni né acqua corrente. “Non mi hanno dato da mangiare per i primi due giorni e ho dovuto vivere e fare pipì nella stessa stanza”. È rimasta lì per due settimane. “Una notte, dopo mezzanotte, tre persone sono entrate nella mia stanza e hanno iniziato a violentarmi a turno”, racconta Darya, ventenne, al Zan Times in un’intervista telefonica.
Quando sua madre venne a sapere del suo arresto, convinse gli anziani della comunità a implorare i talebani per il suo rilascio. Il suo calvario non era finito. “Dopo il mio rilascio, i miei fratelli mi hanno incatenata nella baracca fuori e mi hanno quasi picchiata a morte. Dicevano che avevo portato vergogna alla famiglia e distrutto il buon nome di mio padre. I miei fratelli decisero di uccidermi”, racconta. È sopravvissuta perché sua madre l’ha aiutata a fuggire.
Ciò che rende la situazione degli afghani LGBTQ+ come Darya ancora più difficile è che, oltre a non vedere riconosciuti i loro diritti, i talebani hanno eliminato ogni rifugio sicuro o sistema di supporto. Peggio ancora, vengono perseguitati pubblicamente.
Da quando hanno ripreso il potere, i talebani hanno approvato leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali e autorizzano i funzionari ad agire impunemente. Nell’agosto 2024, il regime ha approvato una legge che includeva un articolo che si riferisce alle identità LGBTQ+ come “atti immorali specifici” – ” sahaq ” per le donne e ” lawatat ” per gli uomini – punibili con l’esecuzione, la lapidazione o il crollo di un muro sulla vittima.
“Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono criminalizzate e soggette a gravi punizioni fisiche, tra cui la fustigazione in pubblico”, afferma il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite Richard Bennett.
Secondo un rapporto della CNN che cita dati di Afghan Witness, tra novembre 2022 e novembre 2024 sono state documentate 43 fustigazioni pubbliche, in cui tra le accuse figurava anche quella di “sodomia”. Questi episodi hanno coinvolto 360 individui: 192 uomini, 40 donne e 128 il cui sesso o genere non è stato identificato.
“Lottare per sopravvivere”
La violenza contro la comunità LGBTQ+ non assume una forma specifica. Tahera, una donna trans di Herat, racconta di essere stata licenziata perché ha un aspetto diverso e “comportamenti femminili”. La perdita del lavoro è stata devastante per la capofamiglia di una famiglia di cinque persone. “La mia famiglia ignora volontariamente che sono trans; vogliono che lavori come un ragazzo”, racconta a Zan Times.
Al giorno d’oggi, gli unici lavori che riesce a trovare riguardano la prostituzione. Trova i suoi clienti su Facebook. La sicurezza è sempre un problema. Qualche settimana fa, ha accettato di incontrare un uomo che le aveva scritto un messaggio su Facebook, scoprendo poi che il suo cliente era un talebano. “Ero spaventata quando l’ho visto, ma lui mi ha detto: ‘Non preoccuparti, sembro un talebano, ma non lo sono'”, racconta Tahera, 25 anni, in un messaggio vocale WhatsApp allo Zan Times. Più tardi, a casa sua, ha mostrato le sue foto mentre era seduto nell’ufficio dell’intelligence. “Mi ha detto: ‘Non ti pagherò, ma devi venire da me ogni volta che te lo chiederò'”, racconta Tahera.
Gli esperti, tra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite, affermano che questi abusi potrebbero costituire crimini contro l’umanità. Citando testimonianze e modelli di abuso, il rapporto Rainbow Afghanistan definisce la condotta dei talebani “sistematica, istituzionalizzata e deliberatamente presa di mira”.
“Mentre altri in Afghanistan lottano per i propri diritti”, afferma Tahera, “noi lottiamo semplicemente per sopravvivere”.
I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati e degli autori.










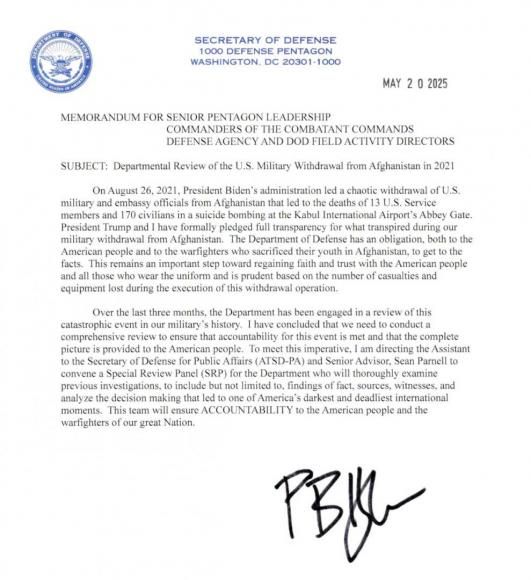
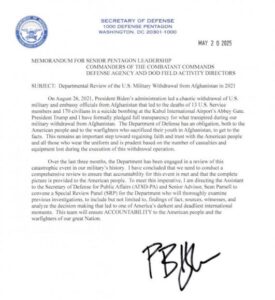


 Haniya Frotan,
Haniya Frotan, 





