La generazione Z in Afghanistan

La trasformazione dell’identità e il futuro della generazione Z in Afghanistan: tra due mondi, alla ricerca del domani
Shafayee Shafayee, 8AM media, 4 novembre 2025
Fatima ha diciassette anni. Quattro anni fa, ogni mattina sedeva in classe accanto alle sue amiche, disegnando silenziosamente mappe nella sua mente, mappe che la portavano a un sogno: diventare medico e curare i malati. Ora, passa la maggior parte del tempo a guardare fuori dalla finestra della sua stanza, a osservare una strada che non ha più il diritto di percorrere. È una degli 1,4 milioni di ragazze afghane a cui è stato vietato di frequentare la scuola dal ritorno al potere dei talebani. Questa non è solo la storia di una ragazza; è la storia di un’intera generazione intrappolata nella frattura della storia, una generazione che un tempo ha assaporato la libertà, ha avuto accesso a internet e al mondo esterno, e poi, da un giorno all’altro, è stata ripiombata in un’oscurità medievale che nemmeno i loro genitori avevano mai sperimentato appieno.
Una nazione giovane, un vecchio regime
Ovunque si vada in Afghanistan, si vedono giovani. L’età media nel paese è di soli diciassette anni, il che significa che la maggior parte degli afghani sono studenti o alle soglie del mondo del lavoro. Circa il 43% dei 42 milioni di abitanti dell’Afghanistan ha meno di quindici anni, oltre 20 milioni di giovani vite che avrebbero dovuto essere la forza trainante del futuro della nazione, ma che ora sono intrappolate nella disperazione e nella miseria. Questa non è una statistica che può essere trascurata. Nessun altro paese della regione ha una popolazione così giovane. Avrebbe potuto essere la risorsa più grande dell’Afghanistan: una vasta forza lavoro, una creatività sconfinata, un’energia illimitata. Invece, è diventata la sfida più scoraggiante del paese.
L’Afghanistan è una terra gravata dalla memoria, eppure abitata da giovani spensierati. Un paese dove secoli di guerra, geografia e destino hanno gravato pesantemente sulle sue spalle, ora ospita una generazione che non appartiene né interamente al passato né al futuro. La Generazione Z in Afghanistan si trova a cavallo tra due mondi, tra tecnologia e tradizione, esilio e patria, silenzio e resistenza, alla ricerca di un nuovo significato dell’esistenza. Questa generazione, che costituisce quasi il 60% della popolazione, è cresciuta tra esplosioni ed esodo, ed è diventata maggiorenne nell’era digitale, in preda a una crisi d’identità. Sono cresciuti in un paese dove le scuole sono state bruciate ma i social media sono ancora vivi; dove i libri sono scarsi, ma gli smartphone si trovano in quasi ogni casa. Lo scontro tra queste due realtà ha creato per loro due narrazioni di vita parallele: una confinata entro confini, segnata da paura e restrizioni; l’altra sconfinata, esistente nel regno virtuale, definita da immaginazione e libertà.
Questi giovani non possono essere paragonati alla generazione dei loro genitori. Sono cresciuti nel ventennio sperimentale della Repubblica, un periodo che, nonostante la corruzione e il caos, ha concesso un breve respiro di libertà. Dal 2002 al 2021, oltre 3,8 milioni di ragazze hanno frequentato la scuola per la prima volta. Questa cifra non è solo un numero; rappresenta milioni di famiglie che, per la prima volta, hanno visto le proprie figlie imparare a leggere e scrivere e, soprattutto, a sognare.
Un tempo le università erano piene di donne. Più di 100.000 studentesse erano iscritte in università pubbliche e private in tutto l’Afghanistan. Oltre 2.400 donne erano docenti. A Kabul, Herat e Mazar-e-Sharif, giovani donne camminavano per le strade con i libri sottobraccio, uno spettacolo che ora sembra un sogno lontano. Questa generazione è cresciuta con i cellulari e internet. Erano attive su Instagram e Facebook, guardavano serie televisive turche e indiane e ascoltavano musica. Il loro mondo si estendeva ben oltre le montagne dell’Hindu Kush.
Caduta libera
E poi, tutto è crollato. Il 15 agosto 2021, il giorno in cui i talebani sono entrati a Kabul, inizialmente avevano promesso che questa volta sarebbe stato diverso. Ma una promessa dopo l’altra è stata infranta. Le scuole femminili oltre la sesta elementare sono state chiuse. Le università sono state prima soggette a restrizioni, poi completamente chiuse. Alle donne è stato impedito di lavorare nelle organizzazioni internazionali. Persino i parchi sono diventati off-limits per loro.
Per ordine del leader supremo dei talebani, le porte delle scuole sono state chiuse a 1,4 milioni di ragazze. Mille giorni di istruzione negata significano tre miliardi di ore di apprendimento perse, tempo che non tornerà mai più. Questa tragedia non riguarda solo le ragazze. I ragazzi, che avrebbero dovuto crescere e imparare insieme alle loro sorelle e compagne di classe, ora assistono alla distruzione di metà della loro società. Sanno che senza la partecipazione delle donne, l’Afghanistan non ha futuro.
Oltre i confini dell’Afghanistan, si sta svolgendo un’altra storia. Milioni di giovani afghani fuggiti dal Paese ora vagano per terre straniere. Oltre 2,6 milioni di rifugiati afghani sono ufficialmente registrati, di cui 2,2 milioni residenti solo in Iran e Pakistan. Ma la realtà è ancora più cupa. Si stima che circa tre milioni di afghani vivano in Iran e forse un altro milione risieda illegalmente in Pakistan e in altri Paesi. Questa generazione in esilio vive con una doppia identità, né pienamente afghana né pienamente appartenente alle nazioni ospitanti. La loro lingua è il dari o il pashtu, ma parlata con un accento che non si sente più a Kabul. La loro cultura rimane afghana, ma si fonde con quella delle società in cui ora vivono. In esilio, nei campi profughi in Pakistan e Iran, o nelle stanze silenziose dell’Europa, stanno costruendo una nuova lingua. Una lingua in cui dolore e speranza si intrecciano. Una lingua globale, ma radicata nella sofferenza locale.
L’opportunità strategica dimenticata
La Generazione Z in Afghanistan non è solo un fenomeno culturale; rappresenta una questione strategica per il futuro della nazione. In un mondo in cui le trasformazioni politiche sono plasmate dai movimenti sociali, questa generazione potrebbe diventare il principale agente di cambiamento o la più grande vittima del silenzio. Nonostante l’accesso alla tecnologia e alle reti globali, rimane priva di supporto strutturale e politico. Nessun programma nazionale di istruzione o sviluppo è stato progettato per comprenderli o rafforzarli.
Mentre il resto del mondo investe nell’istruzione digitale e nell’imprenditorialità giovanile, l’Afghanistan sta tragicamente perdendo il suo “motore del cambiamento”. Ogni giovane che fugge dal Paese e ogni ragazza a cui viene negata l’istruzione distruggono un pezzo del futuro della nazione.
Il costo che tutti pagano
Le conseguenze di questa catastrofe vanno ben oltre i singoli individui. Una società che perde metà del suo potenziale umano è condannata alla povertà e all’arretratezza. Come può esistere un sistema sanitario se non si formano medici donne? Come può funzionare un’economia quando a metà della forza lavoro è impedito di partecipare? Ma al di là dell’economia, questa è una tragedia umana. Ogni ragazza privata dell’istruzione oggi è un’insegnante, un medico, un ingegnere o un leader perso domani. E ogni ragazzo che cresce senza la presenza delle ragazze impara che le donne valgono meno, perpetuando un ciclo infinito di discriminazione.
Un futuro incerto
La domanda ora è: quale destino attende questa generazione nel futuro dell’Afghanistan? Coloro che studiano nelle scuole segrete diventeranno un giorno i leader di un movimento per il cambiamento? Coloro che vivono in esilio torneranno per ricostruire la loro patria? O questa generazione rimarrà sospesa per sempre tra due mondi?
La storia ci ha insegnato che nessun regime può reprimere i suoi giovani all’infinito. I sovietici hanno imparato questa lezione in Afghanistan. La Repubblica, nonostante tutti i suoi difetti, è riuscita a mantenere viva la speranza. E ora i talebani devono rendersi conto che non possono mettere a tacere 20 milioni di giovani per sempre.
Fatima è ancora seduta dietro la finestra, eppure lei e milioni di persone come lei rimangono luci tremolanti nell’oscurità. Le loro voci potrebbero non essere udite oggi, ma la storia dell’Afghanistan dimostra che queste scintille alla fine si trasformano in incendi che nessuno può spegnere.
La domanda non è se il cambiamento avverrà, ma quando e a quale costo.
Alla fine, il futuro dell’Afghanistan non sarà plasmato dai suoi politici dai capelli grigi, ma dalle menti e dai cuori della Generazione Z. Se ne avessero la possibilità, potrebbero riscrivere la storia, una storia fondata non sul sangue e sulla guerra, ma sulla conoscenza e sulla coesistenza.
Nota: questo articolo si basa su dati delle Nazioni Unite, dell’UNICEF, della Banca Mondiale e su rapporti di organizzazioni per i diritti umani.
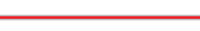


























 Le risorse minerarie e idrocarburifere dell’Afghanistan per troppo tempo non sono state sfruttate nell’ambito dello sviluppo energetico, ma il Governo di Kabul adesso è pronto ad accedere ai tesori del sottosuolo facendo sponda con partner stranieri. Se dapprima gli afghani hanno stretto la mano tesa loro dai cinesi, ora hanno steso i tappeti rossi a un importante attore energetico del Medio Oriente: l’Arabia Saudita. Il 23 ottobre, il ministro delle Miniere e del Petrolio, Mullah Hidayatullah Badri, e l’amministratore delegato della Saudi Delta International Company, Ale Saeed Al-Khayar, hanno sottoscritto un memorandum d’intesa che impegna l’azienda di Riad a investire nell’estrazione di petrolio e gas nella regione e a completare, seppur parzialmente, un’infrastruttura nevralgica per gli equilibri economici-energetici dell’Asia centro-meridionale: il gasdotto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India). Se, da una parte, tale accordo rappresenta un cambio di passo per il mercato di Kabul, dall’altra è la prima pietra per la costruzione di fondamenta solide per l’avvio di una nuova stagione diplomatica e commerciale.
Le risorse minerarie e idrocarburifere dell’Afghanistan per troppo tempo non sono state sfruttate nell’ambito dello sviluppo energetico, ma il Governo di Kabul adesso è pronto ad accedere ai tesori del sottosuolo facendo sponda con partner stranieri. Se dapprima gli afghani hanno stretto la mano tesa loro dai cinesi, ora hanno steso i tappeti rossi a un importante attore energetico del Medio Oriente: l’Arabia Saudita. Il 23 ottobre, il ministro delle Miniere e del Petrolio, Mullah Hidayatullah Badri, e l’amministratore delegato della Saudi Delta International Company, Ale Saeed Al-Khayar, hanno sottoscritto un memorandum d’intesa che impegna l’azienda di Riad a investire nell’estrazione di petrolio e gas nella regione e a completare, seppur parzialmente, un’infrastruttura nevralgica per gli equilibri economici-energetici dell’Asia centro-meridionale: il gasdotto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India). Se, da una parte, tale accordo rappresenta un cambio di passo per il mercato di Kabul, dall’altra è la prima pietra per la costruzione di fondamenta solide per l’avvio di una nuova stagione diplomatica e commerciale.