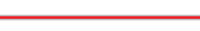«Così puntiamo a cambiare il diritto internazionale»

Il Coordinamento italiano sostegno donne afghane (CISDA) ha lanciato una campagna perché la Corte penale internazionale e l’ONU riconoscano l’apartheid di genere come crimine contro l’umanità. Ne abbiamo parlato con la presidente dell’associazione, Graziella Mascheroni
Giacomo Butti, Il Corriere del Ticino, 22 novembre 2025
Era il 1999 quando l’espressione «apartheid di genere» entrò nelle sale delle Nazioni Unite. Abdelfattah Amor, allora relatore speciale ONU per l’eliminazione delle discriminazioni basate su religione o credo, definì così – «un sistema di apartheid nei confronti delle donne» – il trattamento riservato dai talebani alla popolazione femminile afghana. A quei tempi, le immagini dell’apartheid sudafricano erano fresche nella mente di tutti. Violenza, segregazione, oppressione, negazione dei diritti fondamentali. Era questo che anche le donne afghane stavano vivendo in quel momento, sotto il controllo del primo governo talebano (1996-2001). Ed è questo che stanno vivendo oggi, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, la fine della Repubblica e il ritorno al potere degli «studenti» coranici.
Restrizioni alla libertà di movimento, divieto di studio e lavoro, divieto di parlare in pubblico. A quattro anni dalla caduta di Kabul, ne abbiamo parlato a più riprese, l’Afghanistan è tornato indietro nel tempo. Non è un caso, allora, che l’espressione «apartheid di genere», già largamente utilizzata dalle donne afghane un ventennio fa per descrivere la propria condizione, sia oggi ancora in uso. Ed è per questo che un gruppo della vicina Penisola, il Coordinamento italiano sostegno donne afghane (CISDA), punta a portare nuovamente il tema sotto i riflettori internazionali, con un’iniziativa che chiede che l’apartheid di genere sia riconosciuto quale crimine contro l’umanità (come già è il caso per l’apartheid razziale) all’interno dei Trattati internazionali. Ne abbiamo parlato con Graziella Mascheroni, presidente del CISDA.
La raccolta firme
Sin dal 1999 il CISDA è attivo per promuovere progetti di solidarietà a favore delle donne afghane. Ma nel suo statuto, voce “Oggetto e scopi”, viene esplicitato: tra gli obiettivi dell’associazione c’è quello di «realizzare una crescita ed uno sviluppo, sia a livello locale che internazionale, nella ricerca di una maggiore giustizia tra i popoli». Non stupisce, allora, che l’ente non profit si sia lanciato in un’azione particolarmente ambiziosa: cambiare il diritto internazionale, per combattere l’apartheid di genere in Afghanistan e nel mondo.
«Per lanciare il nostro progetto abbiamo lavorato in modo molto approfondito, consultandoci con giuristi ed esperti di diritto internazionale», ci racconta Mascheroni. «Da questa collaborazione è nato un documento sul quale abbiamo basato la campagna “Stop fondamentalismi – Stop apartheid di genere“».
La campagna, si legge sul sito del CISDA, chiede che l’apartheid di genere sia riconosciuto come crimine contro l’umanità e si riconosca che tale crimine viene applicato sistematicamente e istituzionalmente in Afghanistan. Inoltre, al fine di non legittimare i fondamentalisti al governo a Kabul, il CISDA chiede che l’ONU non dia riconoscimento né giuridico né di fatto al regime talebano, che il fondamentalismo talebano sia dichiarato illegale, che sia impedito il finanziamento e l’invio di armi da Paesi amici, che i rappresentanti talebani siano estromessi da incontri di diplomazia internazionale e riunioni ONU.
La petizione collegata alla campagna, aperta a dicembre 2024 e chiusa lo scorso aprile (ma firmare è ancora possibile), ha raccolto circa 2.000 firme e il sostegno di un’ottantina di associazioni. «La raccolta firma è stata inviata al governo italiano, perché si faccia portavoce degli obiettivi della campagna dinanzi alle istituzioni internazionali. Siamo in attesa, ora, di avere un’audizione in Senato», ci spiega Mascheroni, che sottolinea: «Il documento è stato inviato anche alla Sesta commissione ONU e alla Corte penale internazionale (CPI). Quest’ultima ci ha risposto spiegando i prossimi passi». Un grande orgoglio per una associazione come il CISDA, ci spiega la presidente, che tuttavia non si fa illusioni: «C’è ancora tantissimo da fare». Perché questa proposta di modifica dello Statuto di Roma (il trattato internazionale istitutivo della CPI) venga presa in considerazione, dovrà essere patrocinata da uno Stato membro. «Negli ultimi mesi ci siamo mossi per cercare l’appoggio di un Paese che senta l’importanza di questo tema». Sudafrica e Congo sono tra i papabili, ma ci vorrà ancora del tempo perché vengano avanzate proposte concrete. Certo è che se l’iniziativa dovesse avere successo, l’impatto sarebbe fondamentale, e globale.
La situazione in Afghanistan
Per le donne afghane ogni mese conta, perché ogni mese è peggiore del precedente. «La situazione continua a deteriorarsi», conferma la presidente del CISDA, che con i gruppi locali di sostegno alle donne mantiene stretti contatti. «E questo anche per colpa del progressivo riconoscimento – formale o informale – da parte di Paesi terzi, che con i talebani stanno portando avanti rapporti diplomatici». Proprio negli scorsi giorni, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha confermato di aver «invitato rappresentati del governo talebano non ufficiale all’aeroporto di Ginevra» per trattare il tema delle espulsioni di cittadini afghani verso il loro Paese d’origine. Negoziazioni che hanno permesso il ristabilimento di un canale con l’Afghanistan per le espulsioni di uomini la cui domanda di asilo è stata respinta.
A Kabul, intanto, le donne di RAWA – l’Associazione rivoluzionaria delle donne afghane, gruppo politico, sociale e umanitario a sostegno di tutta la popolazione afghana – non hanno intenzione di mollare di fronte alle terribili condizioni di vita. «Le sentiamo regolarmente. Sono convinte che nessun vero cambiamento possa venire dall’esterno. Dicono che giustizia e libertà possano giungere solo attraverso la lotte cosciente e unita della popolazione. Questo è il credo di RAWA, che dagli anni Settanta – dall’invasione sovietica, passando per guerre civili, i governi talebani e anche il periodo americano – non ha mai smesso di lottare. Loro vivono da sempre in clandestinità e quindi stanno portando avanti il loro lavoro come fatto in passato. Più difficile, invece, operare per le ONG che fino a qualche anno fa lavoravano indisturbate e oggi devono stare invece molto attente alla sorveglianza dei talebani per portare avanti in segreto la formazione delle bambine, la cui istruzione è stata proibita».
Chi non fa parte di associazioni o gruppi, porta avanti l’opposizione come può. «Con il progressivo assestarsi del potere talebano, scendere in strada come nei mesi seguenti la caduta di Kabul non è più possibile. La resistenza si è quindi spostata sui social. Non è un caso se nelle ultime settimane alcune regioni dell’Afghanistan abbiano subito un blocco dell’accesso alla rete». E questo fenomeno, ci racconta Mascheroni, non riguarda solo le donne. «Tutta la popolazione è stanca, e anche gli uomini sono contrari al dominio talebano. La società afghana è patriarcale: nei centri abitati al di fuori delle grandi città, i capi villaggio sono esclusivamente uomini. Eppure collaborano strettamente con le associazioni femminili con cui siamo in contatto, specialmente nelle zone colpite recentemente dai terremoti, dove i talebani si sono ben guardati dal portare aiuti».
L’importanza dell’alfabetizzazione
Parallelamente alla campagna contro l’apartheid di genere, da anni il CISDA porta avanti una lunga serie di progetti in Afghanistan a sostegno della popolazione. «Grazie a un nostro generoso sponsor, a Kabul e in altre quattro province possiamo finanziare un corso di cucito che garantisce, parallelamente, l’alfabetizzazione delle bambine. Contemporaneamente sosteniamo un’unità mobile, un team sanitario che va di villaggio in villaggio a visitare i pazienti». In passato l’organizzazione italiana, spiega la presidente, finanziava «grandi case protette per le donne afghane, ma molte sono state chiuse dopo l’arrivo dei talebani nel 2021. In questo momento, quindi, stiamo aiutando uno “shelter” più piccolo – che passa quindi inosservato – che al momento ospita quattro donne vittime di violenza e i loro 9 figli». Ma non finisce qui. «Da una decina d’anni, il nostro progetto Vite preziose permette il sostegno a distanza per chi ha subito violenze: così sponsor esterni possono aiutare finanziariamente, di solito per un anno, una donna afghana in difficoltà. Giallo fiducia, invece, supporta una coltivazione di zafferano nelle zone di Herat. Le dodici donne che lavorano in questo campo partecipano a un corso di alfabetizzazione e a uno sui diritti umani».
Piccoli numeri che, moltiplicati per la loro capillarità, fanno la differenza in una resistenza che vede l’alfabetizzazione, come già evidenziato, tema principale. «In risposta alla chiusura degli istituti scolastici, sono sorte migliaia di piccole scuole clandestine che, sparse un po’ ovunque, vedono insegnanti mettere a disposizione la propria casa per portare avanti la formazione di piccoli numeri di ragazze. La risposta a simili iniziative è alta, perché c’è la consapevolezza che l’istruzione è alla base della società. Senza, ottenere o mantenere libertà diventa molto più difficile».