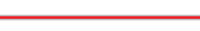Se le tendenze attuali persisteranno, entro la fine del decennio oltre 351 milioni di donne e ragazze potrebbero ancora vivere in condizioni di povertà estrema
Ana Carmo, News Nazioni Unite, 15 settembre 2025
Il mondo si sta allontanando dalla parità di genere e il costo si sta contando in termini di vite umane, diritti e opportunità. A cinque anni dalla scadenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) nel 2030, nessuno degli obiettivi per la parità di genere è sulla buona strada.
È quanto emerge dal rapporto SDG Gender Snapshot di quest’anno, pubblicato lunedì da UN Women e dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, che si basa su oltre 100 fonti di dati per monitorare i progressi in tutti i 17 obiettivi.
Il mondo a un bivio
Il 2025 segna tre importanti traguardi per le donne e le ragazze: il 30° anniversario della Dichiarazione e della Piattaforma d’azione di Pechino , il 25° anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e l’ 80 ° anniversario delle Nazioni Unite .
Ma alla luce dei nuovi dati preoccupanti, è urgente accelerare azioni e investimenti.
Altri risultati del rapporto rivelano che la povertà femminile non è praticamente cambiata negli ultimi cinque anni, attestandosi intorno al 10% dal 2020. La maggior parte delle persone colpite vive nell’Africa subsahariana e nell’Asia centrale e meridionale.
Il conflitto amplifica la crisi
Solo nel 2024, 676 milioni di donne e ragazze vivevano a rischio di conflitti mortali, il numero più alto dagli anni ’90.
Per chi si trova in zone di guerra, le conseguenze vanno ben oltre lo sfollamento. Insicurezza alimentare, rischi per la salute e violenza sono in forte aumento, osserva il rapporto.
La violenza contro donne e ragazze rimane una delle minacce più diffuse. Più di una donna su otto in tutto il mondo ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner nell’ultimo anno, mentre quasi una giovane donna su cinque si è sposata prima dei 18 anni. Ogni anno, si stima che quattro milioni di ragazze subiscano mutilazioni genitali femminili, e oltre la metà di esse prima del quinto compleanno.
Dare priorità alla parità di genere
Eppure, nonostante le statistiche fosche, il rapporto evidenzia cosa è possibile fare quando i paesi danno priorità alla parità di genere. La mortalità materna è diminuita di quasi il 40% dal 2000 e le ragazze hanno ora più probabilità che mai di finire la scuola.
Parlando con UN News , Sarah Hendriks, direttrice della Divisione politica di UN Women, ha affermato che quando si è trasferita per la prima volta in Zimbabwe nel 1997, “dare alla luce era in realtà una questione di vita o di morte”.
“Oggi questa non è più la realtà. E questo è un progresso incredibile in soli 25, 30 anni”, ha aggiunto.
Colmare il divario digitale di genere
Anche la tecnologia è promettente. Oggi, il 70% degli uomini è online, rispetto al 65% delle donne. Colmare questo divario, stima il rapporto , potrebbe portare benefici a 343,5 milioni di donne e ragazze entro il 2050, facendo uscire 30 milioni di persone dalla povertà e aggiungendo 1,5 trilioni di dollari all’economia globale entro il 2030.
“Laddove la parità di genere è stata considerata prioritaria, ha fatto progredire società ed economie”, ha affermato Sima Bahous, Direttore Esecutivo di UN Women. “Investimenti mirati nella parità di genere hanno il potere di trasformare società ed economie”.
Allo stesso tempo, una reazione senza precedenti ai diritti delle donne, la riduzione dello spazio civico e il crescente taglio dei finanziamenti alle iniziative per la parità di genere stanno minacciando i successi ottenuti a fatica.
Secondo UN Women, senza azioni concrete le donne restano “invisibili” nei dati e nell’elaborazione delle politiche, con il 25% in meno di dati di genere disponibili a causa dei tagli ai finanziamenti per le indagini.
“Il Gender Snapshot 2025 dimostra che i costi del fallimento sono immensi, ma lo sono anche i guadagni derivanti dalla parità di genere”, ha affermato Li Junhua, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali.
“Un’azione accelerata e interventi focalizzati su assistenza, istruzione, economia verde, mercati del lavoro e protezione sociale potrebbero ridurre il numero di donne e ragazze in povertà estrema di 110 milioni entro il 2050, sbloccando un ritorno economico cumulativo stimato in 342 trilioni di dollari”.
Scelta urgente
Ma i progressi restano disomogenei e spesso dolorosamente lenti.
Le donne detengono solo il 27,2% dei seggi parlamentari in tutto il mondo e la loro rappresentanza negli enti locali si è fermata al 35,5%. Nella dirigenza, le donne occupano solo il 30% dei ruoli e, a questo ritmo, la vera parità è lontana quasi un secolo.
In occasione del 30° anniversario della Piattaforma d’azione di Pechino, il rapporto definisce il 2025 come un momento di resa dei conti.
“L’uguaglianza di genere non è un’ideologia”, avverte. “È fondamentale per la pace, lo sviluppo e i diritti umani”.
In vista della settimana di alto livello delle Nazioni Unite, il rapporto Gender Snapshot chiarisce che la scelta è urgente: investire subito nelle donne e nelle ragazze, oppure rischiare di perdere un’altra generazione di progressi.
La signora Hendriks ha condiviso il messaggio di UN Women ai leader mondiali: “Il cambiamento è assolutamente possibile e abbiamo davanti a noi un percorso diverso, ma non è inevitabile e richiede la volontà politica, nonché la ferma determinazione dei governi di tutto il mondo, per rendere l’uguaglianza di genere, i diritti delle donne e la loro emancipazione una realtà una volta per tutte”.
Basato sull‘Agenda d’azione Pechino+30 , il rapporto individua sei aree prioritarie in cui è necessario un intervento urgente e accelerato per raggiungere la parità di genere per tutte le donne e le ragazze entro il 2030, tra cui una rivoluzione digitale, la libertà dalla povertà, zero violenza, pieno e pari potere decisionale, pace e sicurezza e giustizia climatica.